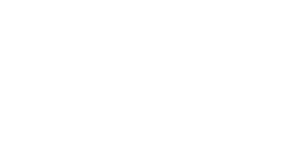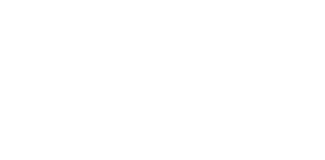Dal caso sullo stupro di Palermo è imperativo imparare cosa non dobbiamo fare in rete
Ci sono state tante, troppe cose sbagliate nella narrazione online dello stupro di Palermo. Errori che, se non compresi, rischiano di essere commessi ancora
25/08/2023 di Ilaria Roncone
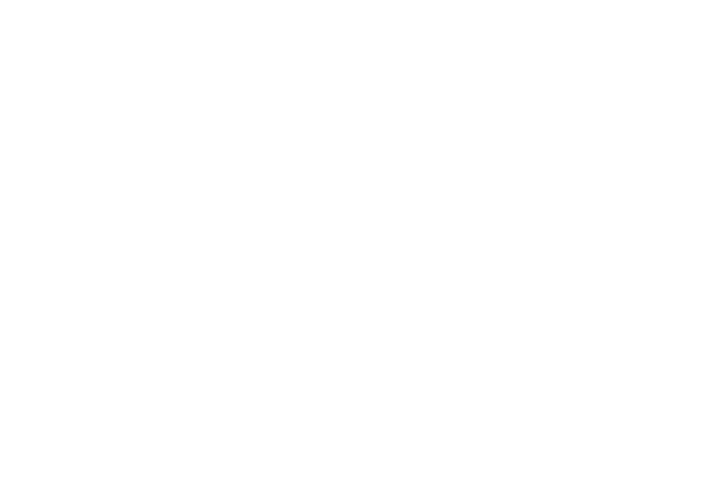
L’episodio dello stupro di Palermo lo ricorderemo non solo per l’efferatezza di quanto accaduto ma anche perché, a livello social e a livello stampa online, tutti gli errori che potevano essere fatti sono stati fatti. Purtroppo nella giornata di oggi, parlando di quell’episodio, è inevitabile inserirne anche uno appena emerso: quello dello stupro di gruppo di Caivano. Le modalità sono le stesse, un gruppo di maschi si accanisce su due ragazze. Con un’aggravante ulteriore: dei sei ragazzi solo uno è maggiorenne mentre le ragazze che hanno denunciato l’aggressione sono due cugine di appena tredici anni. Episodio che, se non si analizza la questione oggetto di questo articolo, rischia di essere raccontato nello stesso modo portando le stesse conseguenze alle vittime.
LEGGI ANCHE >>> Le piattaforme che fanno l’educazione sessuale che la scuola italiana non fa
Tra cronaca e divulgazione, gli errori nel racconto dello stupro di Palermo
Fare (bene) cronaca e divulgazione su casi di violenza non è facile. Partiamo chiarendo un punto: per errori vogliamo intendere, in questo articolo, anche quelle comunicazioni fatte per divulgare ciò che stava avvenendo – nei giorni in cui la vicenda è emersa – con la migliore intenzione e di evidenziare le storture nelle narrazioni dei giornali e nell’utilizzo di TikTok e di Instagram in un contesto tanto delicato. Colei che scrive si è interrogata molto in questi giorni, riflettendo sulle modalità di comunicazione e fruizione delle notizie che passano attraverso Instagram – il social dove tanti divulgatori e divulgatrici si impegnano su queste tematiche, presidiato anche dai giornali – e sulle tempistiche di queste modalità che, evidentemente, non possiamo più ignorare.
Una vicenda così delicata, come qualunque storia di violenza, una volta che viene a galla mette chi indaga e chi ne parla nella posizione di proteggere l’identità della vittima. Per quanto riguarda il lavoro giornalistico, questo è stato sancito anche dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 22 febbraio 2021 n. 4690. Chi ne parla, però – e con il caso di stupro di Palermo lo abbiamo visto molto bene – non sono sempre e solo i giornalisti sulle testate. Giornalisti che – aprendo una piccola parentesi – come abbiamo avuto modo di vedere negli anni, spesso e volentieri – al di là delle testate che lo fanno con intenzionalità – non si dimostrano in grado di parlare di tematiche relative alla violenza su determinati gruppi di persone (siano donne o persone della comunità LGBTQIA+).
Tornando al centro della questione, abbiamo visto anche moltissime persone (attiviste, autrici, scrittrici, persone facenti pare della comunità) spendere storie, reel e post per raccontare lo stupro da un altro punto di vista, quello di chi comprende i meccanismi del patriarcato, compiendo il sacrosanto lavoro di decostruzione della narrazione politica che spesso è troppo semplicistica (si veda, per esempio, l’immediata reazione di Roccella che vuole limitare il porno per i minori) e affermando con forza: siamo inca**ate, non ce la facciamo più e dovreste anche voi (in riferimento agli uomini) arrabbiarvi perché siamo in un mondo in cui queste cose accadono alle donne in maniera sistemica.
Raccontare sui social, però, mette in pericolo l’identità della vittima
Prima di chiarire che cosa intendiamo, partiamo dalle basi. Capitolo Telegram: su Telegram, lo sappiamo da anni, esistono gruppi in cui centinaia di migliaia di uomini si uniscono scambiandosi materiale pedopornografico su mogli, sorelle, figlie, ex o anche donne sconosciute. Quando si verificano casi di violenza sessuale, questi uomini vanno alla ricerca dei video della violenza. Il giornalismo ha dovuto presto imparare, così come i divulgatori, che non censurare i nomi di questi gruppi narrando il fenomeno fa sì che gli iscritti aumentino notevolmente in corrispondenza di eventi come questo. Per il caso dello stupro di Palermo non è stato diverso. Su Telegram, inoltre, si assiste anche a casi di phishing per cui chi clicca su un link (solitamente accompagnato dall’immagine della diciannovenne trascinata dagli stupratori che tristemente abbiamo imparato a riconoscere) si imbatte in truffe, vedendosi il telefono infettato.
Ma spostiamoci su TikTok, il social protagonista delle peggiori derive legate a questa specifica vicenda (al di là dell’utilizzo che ne ha fatto uno degli indagati, il minorenne tornato in carcere anche per quello che ha fatto sui social dopo essere stato rilasciato la prima volta). Situazioni che, spesso e volentieri, non sono neanche immaginabili per chi non lo utilizza ma che sono il pane quotidiano della Gen Z e dei più giovani che, su quel social e in assenza di altri tipi di formazione (come abbiamo spiegato, in Italia a scuola educazione sessuale non si fa) scoprono il sesso anche attraverso quel mezzo. Mezzo che, troppo spesso, utilizzano senza comprenderne i meccanismi algoritmici e le conseguenze sul reale.
Quando la storia è venuta fuori è stato creato un profilo fake attribuito a uno degli stupratori. Su questo profilo sono stati presi suoi vecchi video, ricontestualizzandoli con scritte relative allo stupro. Risultato: l’accusato si vantava della vicenda e le persone si sono affrettate ad andare a commentare, regalando sempre più visibilità a un profilo fake e a chi quel profilo lo ha creato. Ciò dimostra come sui social sia sempre più difficile – anche per chi ci vive ogni giorno – capire cosa sia vero e cosa sia falso se non ci alfabetizziamo. E a sbagliare, riportando in maniera acritica la vicenda, sono stati anche noti giornalisti social e testate rinomate, riportando i video di quel profilo come se fossero reali.
Ma torniamo alla vittima, la cui identità è stata effettivamente rivelata a partire da TikTok. La giovane, in determinate circostanze, è stata menzionata e tutti hanno cominciato a chiedere se fosse lei. Arrivata la conferma, è partita la gara a chi (menzionandola) esprimeva più solidarietà. Risultato? L’identità della vittima, che prima era a riparo – nota, probabilmente, “solo” nel contesto palermitano – è stata messa alla mercé di tutta Italia. Ci sono divulgatori che, giustamente, hanno immediatamente fatto presente la cosa denunciando questo utilizzo assolutamente indecente e proprio dei social.
Ed è qui che è partita la riflessione di chi scrive. Parlare su Instagram del fatto che su TikTok l’identità della giovane fosse stata rivelata ha permesso a me di trovare nome e profili social della diciannovenne in due minuti. A me come a chiunque altro. Ed è questo il fulcro centrale del ragionamento, il circolo vizioso e il cane che si morde la coda, quello da cui non si esce (almeno così sembra, per ora): parlare sui social (e poi, di riflesso, sui giornali) di questo episodio non può aver contribuito ad aumentare ancora di più l’attenzione sulla vittima, procurandole altro dolore – oltre a quello di vedere le proprie immagini ovunque, a sapere che c’è chi quel video lo cerca incessantemente su Telegram – e rendendo nota la sua identità a un numero di persone enorme, ancora maggiore rispetto a come sarebbe stato se fosse rimasto “solo” su TikTok?
La domanda generata da questa riflessione è fatta senza alcun tipo di polemica e vuole essere un invito a riflettere in maniera collettiva su un fatto che ormai è sotto gli occhi di tutti: parlare sui social di episodi di violenza è necessario per diffondere una consapevolezza sempre maggiore e portare più persone a riflettere su queste tematiche, però forse bisognerebbe farlo con tempistiche diverse. Aspettando, magari, che si sgonfi l’attenzione mediatica e divulgandolo poi, con maggiore freddezza e in maniera più ragionata anche rispetto alle possibili conseguenze, quando è più difficile per chi cerca quel video, quella foto, quel nome scandagliare i meandri di internet e ottenere ciò che vuole.