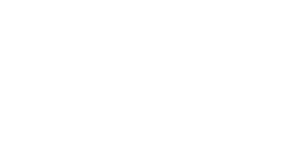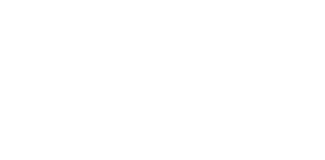Perché il Covid-19 sta mettendo in crisi la religione del nostro tempo
23/03/2020 di Daniele Tempera
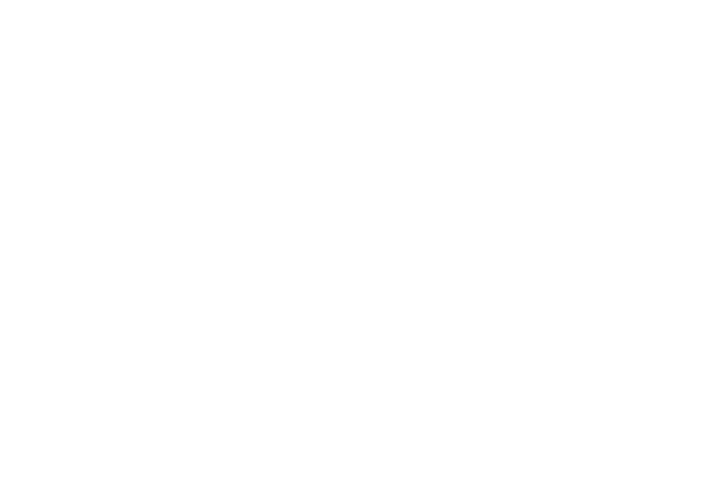
Ci sono voluti quasi 800 morti al giorno e un annuncio, in diretta Facebook la notte dello scorso 21 marzo, per interrompere tutte le attività produttive considerate “non necessarie” e provare a spingere sull’acceleratore nella lotta contro il Covid-19. Una misura su cui tuttora esistono forti polemiche. C’è voluto il paradosso delle due città simbolo della produzione industriale italiana, con fabbriche e aziende continuavano a produrre e i lavoratori a lavorare, mentre l’esercito portava via i corpi che i forni crematori di Brescia e Bergamo non riuscivano più a “smaltire”. Una guerra combattuta mentre attorno il business è continuato per settimane e giorni “as usual”. Una prerogativa non solo italiana.
Negli scorsi giorni abbiamo ascoltato il premier Boris Johnson affermare, candidamente, che l’infezione da nuovo coronavirus era ormai “inevitabile”, che avrebbe colpito il 60% dei britannici e così si sarebbe raggiunta la cosiddetta “immunità di gregge” con la puntualizzazione: «Abituatevi a perdere i vostri cari». Una frase che mi ha istintivamente ricordato quella pronunciata da Mussolini prima dell’entrata in guerra italiana nella Seconda Guerra Mondiale: «Mi serve qualche migliaio di morti per sedermi al tavolo delle trattative».
Sì, perché se quella contro il Covid-19 è una guerra, è indubbio che la vera guerra strisciante è sempre quella tra aziende grandi e piccole, fondi azionari e speculativi, multinazionali e stati nazione. Ed è altrettanto indubbio che ne uscirà vincitore chi riuscirà a minimizzare le perdite tenendo insieme il settore economico-industriale, senza rinunciare alle filiere essenziali e alle commesse rilevanti, a scapito degli altri. Chi sarà in grado di disinnescare la bomba sociale che deriverà dalla crisi dei tanti piccoli imprenditori e dipendenti che stanno perdendo commesse, salari e spesso lavoro e ricchezze. Una cosa che traspariva nitidamente anche dalle dichiarazioni del Macron pre-lockdown («Non rinunceremo alle nostre libertà») o al Trump che paragonava questa infezione a un’influenza.
Meno Stato: un mantra lungo 30 anni
Il punto non è forse limitarsi alla polemica politica quotidiana, cavalcata di volta in volta da opposizioni che avrebbero agito esattamente allo stesso modo, ma allargare lo sguardo. E il nostro sguardo ci dice che questa partita, malgrado le aperture di Fed e Bce, si sta ancora giocando con le stesse medesime regole che osserviamo da più di 30 anni e che tutti i leader politici mondiali, pena il loro fallimento, sono chiamati ad applicare rigorosamente. Un paradigma che ha visto il pubblico come un intralcio (salvo quando si è trattato di salvare banche in default, ad esempio). Il mantra? Semplice: l’unico compito dello Stato è quello di permettere il corretto funzionamento del libero mercato che, per sua natura, tende ad autoregolarsi. Un mantra che è rimasto pressoché invariato, anche quando i conti di un’economia, caratterizzata sempre più da un capitalismo finanziario rapace basato sull’estrazione di valore, piuttosto che sulla sua produzione, non tornavano.
Tutto ciò ha un nome, spesso abusato nel dibattito di questi anni, ma che si è spesso identificato con un’ideologia capace di racchiudere l’intera realtà, come spiegava il sociologo Luciano Gallino: «il neoliberalismo è giunto a configurarsi nella società contemporanea come una costruzione che, nel suo ambito, la fisica ambisce da generazioni a realizzare, senza peraltro riuscirvi: niente di meno che una teoria del tutto. Essa propone di sottomettere ogni dimensione dell’esistenza alla razionalità economica, il culmine della quale è il calcolo di costi e benefici cui deve sottostare ogni azione umana». Una razionalità che non contempla l’esistenza di uno Stato particolarmente attivo, visto per sua natura come una perversione dei virtuosi rapporti di forza del libero mercato che non contempla, a sua volta, l’esistenza stessa di soggetti collettivi. Come disse l’ex primo ministro Margaret Thatcher, una delle protagoniste assolute della svolta liberista britannica e mondiale: «Come sapete, la società non esiste. Esistono gli individui, gli uomini e le donne, ed esistono le famiglie. E il governo non può fare niente se non attraverso le persone, e le persone devono guardare per prime a sé stesse».
Va di per sé che non esistono “beni comuni” da salvaguardare: «Il neoliberalismo incorpora una teoria inversa dei beni comuni: di qualsiasi bene l’individuo e la collettività abbiano bisogno ai fini della loro convivenza e protezione sociale, detta teoria afferma con perentoria sicurezza, è più efficiente e dunque necessario produrlo con mezzi privati. In sintesi l’ideologia neoliberale non riconosce, né ha di fatto, alcun confine […] un carattere costitutivo del neoliberalismo è proprio quello di essere , nel fondo, una forma di fede» per dirla, ancora una volta, con le parole di Luciano Gallino.
E a conti fatti quello dell’ultraliberismo, e dell’individualismo annesso, è stata davvero l’unica vera fede del nostro tempo. Un recinto dal quale non ci è è dato uscire, pena l’emarginazione vera. Le uniche forme di dissenso di massa della mia generazione si sono condensate prima nell’autodistruzione (grunge docet) poi sono state sublimate nell’ironia, nei meme da social network, nella costruzione di “nicchie di consapevolezza”, nei partiti votati allo “0 virgola”, nel cinismo, nell’estetica da apocalisse imminente e in quello che lo scrittore americano David Foster Wallace, ormai più di 20 anni fa, definiva l’incapacità di “diventare genitori”.
“Cigni neri” e altri disastri
Mentre i paradossi dell’economia neoliberale e delle speculazioni finanziarie annesse distruggevano le nostre vite con precarietà esistenziale e crisi cicliche e devastanti e il pianeta, con una catastrofe ambientale che minaccia la nostra stessa sopravvivenza, il motto, implicito, è stato sempre il solito: “Non c’è alternativa”.
Una canzone di metà anni ’90 del Consorzio Suonatori indipendenti recitava “È l’instabilità che ci fa saldi ormai, negli sradicamenti quotidiani”. E la nostra vita di sradicamenti ne ha avuti non pochi e non sempre piacevoli. Un paradosso. Sì, perché il cammino degli uomini, dai primi Sapiens in poi, è sempre stato quello di creare comunità per arginare e prevedere le catastrofi e l’imprevedibilità dell’esistenza. Ci siamo scoperti, negli ultimi 30 anni alla mercé di forze economiche incontrollabili su cui poco potevano influire le nostre scelte democratiche e abbiamo già visto come tutto ciò abbia riportato a galla vecchi e nuovi fascismi e nazionalismi. Ora siamo di nuovo a tu per tu con qualcosa di nuovo e imprevedibile. Ancora una volta la affrontiamo con quello che abbiamo. Una fede che ha allontanato dal nostro orizzonte mentale la morte. E se tutti sperimentano, presto o tardi, la portata di questa illusione a livello personale, ora la dimensione si è fatta collettiva e urgente.
Siamo di nuovo a contatto con la nostra fragilità primordiale, con un virus impensabile fino a qualche mese fa, che ci ricorda che lo Stato e le istituzioni sono costruzioni sociali per tutelarci dai “Cigni Neri” come il Covid-19 e dell’imprevidibilità dell’esistente. Quell’imprevedibilità che il positivismo acritico del neoliberismo non ha mai preso seriamente in considerazione. È presto per ipotizzare cosa succederà, ma non abbastanza per capire che qualcosa abbia intaccato, per sempre, la “religione del nostro tempo”.