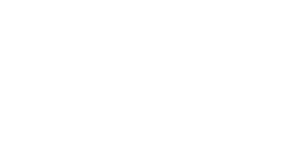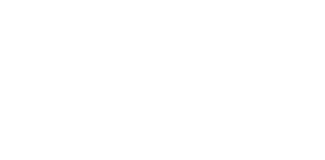Per tassare le Big Tech servono nuove imposte ad hoc: l’intervista a Stefano Dorigo
Abbiamo fatto una chiacchierata con Stefano Dorigo, docente esperto di Diritto tributario, per tratteggiare il panorama in cui gli Stati del mondo si stanno muovendo per attuare una tassazione efficace delle Big tech
23/02/2023 di Redazione Giornalettismo
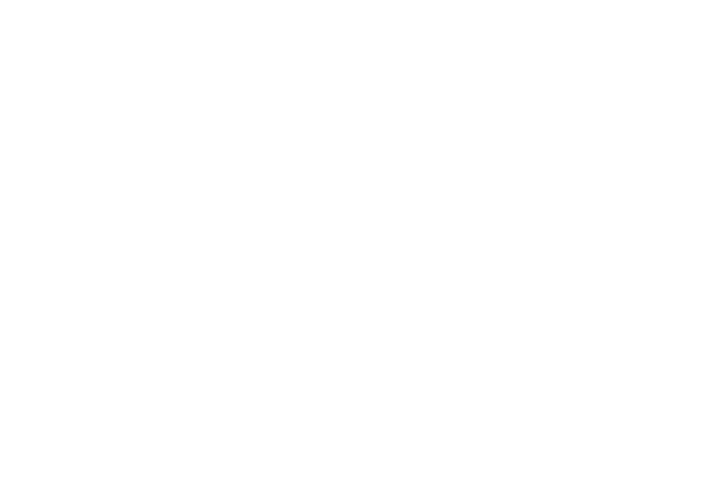
Cosa comporta l’inchiesta sulla presunta evasione di Meta dal momento in cui dovesse essere stabilito che, effettivamente, i dati sono merce che deve essere soggetta a tassazione (nello specifico l’IVA)? Ne abbiamo parlato con Stefano Dorigo, professore associato che insegna Diritto Tributario presso l’Università di Firenze e co-autore del libro “Fiscalità dell’economia digitale” edito da Pacini. La lunga intervista si è chiusa con una certezza e con una frase che scegliamo di utilizzare per cominciare, ovvero che una cosa è certa: «Per uno studioso di diritto tributario internazionale come me questo è un periodo davvero fecondo di prospettive e attese: vedremo alla prova dei fatti se prevarrà la forza del diritto sugli interessi privati delle Big Tech». L’unica cosa certa è che si tratta di una materia nuova, complessa e che necessità di nuove imposte create ad hoc che mettano al centro beni immateriali come il dato.
LEGGI ANCHE >>> Quali sono le basi dell’inchiesta sulla presunta evasione fiscale da 870 milioni di Meta?
Stefano Dorigo sulla tassazione Big Tech, tra tentativi inefficaci e falliti
Quanto senso ha la lettura che sta dando la procura e quante sono le possibilità che, alla fine di tutto questo, ci troviamo in un mondo che preveda il pagamento dell’IVA da parte di Big Tech in Italia e delle tasse analoghe negli altri paesi europei? «La problematica fiscale legata alle multinazionali digitali è stata, sin qui, caratterizzata dall’affannosa rincorsa, da parte dei legislatori nazionali, di fenomeni per loro natura nuovi e rapidissimi», spiega lo studioso.
«Le vecchie categorie impositive, pensate per un’economia tradizionale e materiale, non hanno consentito subito di intercettare una situazione nella quale un’impresa multinazionale può produrre redditi ovunque nel mondo senza avere, di fatto, da nessuna parte alcuna presenza fisica (in termini di sede ma anche di beni e servizi offerti che sono dematerializzati) e, di conseguenza, senza pagare imposte negli Stati degli utenti», prosegue Dorigo.
«La domanda che ci si è posti è dunque stata: questi redditi dove si possono ritenere prodotti? E quindi quale Stato ha diritto a sottoporli alle proprie imposte? Ebbene – afferma il docente, evidenziando quello che è stato fatto finora -questo dibattito che ha condotto a una serie di tentativi di regolamentazione, alcuni falliti in partenza (come le proposte di direttiva UE del 2018), altri in forte ritardo (come le iniziative OCSE sull’economia digitale), altri ancora inefficaci in quanto unilaterali (come la webtax italiana), ha sin qui lasciato in secondo piano il tema dei dati. Che al contrario è centrale, sia perché sono i dati la vera fonte di ricchezza dell’economia digitale, sia perché i dati riconducono a un certo territorio e quindi potrebbero rappresentare un valido collegamento col sistema fiscale di un certo Stato».
Pregi e limiti dell’inchiesta evasione Meta
«L’inchiesta in corso su Meta sembra concentrarsi proprio sui dati, sebbene non con riferimento alle imposte dirette (che sono quelle che portano maggiore gettito agli Stati) ma all’IVA. Mi pare che l’approccio sia meritevole di considerazione, perché per la prima volta collega l’imposizione al dato. Certo che non tutto appare lineare o scontato», sottolinea Stefano Dorigo provando ad avere uno sguardo critico che possa andare oltre questa grande novità.
«Ad esempio, non è detto che si sia di fronte realmente ad una permuta, sappiamo bene che l’individuo “schiavo digitale” (come lo definisce Stefano Mannoni) non percepisce il dato come un bene oggetto di un diritto di proprietà, tanto che è disposto a conferirlo alle piattaforme senza alcun accorgimento, dal momento che la partecipazione al servizio digitale è vista come indispensabile. Non è ben chiaro, poi, se tale servizio (ad esempio l’accesso a un social) sia davvero un servizio avente natura commerciale, ma -soprattutto – manca una qualsiasi possibilità realistica di attribuire un valore a tale ipotetica transazione: non esiste un mercato dei dati, quindi nessuno può affermare con oggettività che quel dato conferito abbia un certo valore, sulla base del quale calcolare l’imposta dovuta. C’è, infine, il tema della territorialità, ovvero di quale Stato possa sottoporre ad IVA quell’importo, che mi pare resti ancora senza risposta. In definitiva: apprezzabile lo sforzo di centrare la tassazione sul dato, restano molte perplessità sulla reale tenuta di questo schema di fronte alle incertezze che ho segnalato. Ma non c’è dubbio che il futuro della tassazione dell’economia digitale non possa prescindere dai big data», termina di elencare il professore. Non dovrebbe essere la sentenza di un giudice a decidere queste regole (uno potrebbe interpretare in un modo, uno in un altro) ma una legislazione».
In conclusione, quello che Stefano Dorigo vuole ricordare – al di là del merito di concentrarsi sul dato nell’approccio – è che «la soluzione a problemi così complessi data da indagini penali o da attività delle amministrazioni finanziarie». Il quadro di incertezza normativa in cui ci troviamo, infatti, non andrebbe alimentato ma sanato: questo vuol dire che «dovrebbe essere il legislatore, e non l’amministrazione o un giudice, a stabilire le regole impositive».
Per avere successo servono nuove imposte ad hoc
Le criticità, limitandosi all’IVA, sono tante: «Il rischio – spiega il professore ai microfoni di Giornalettismo – è che il costo fiscale finisca per gravare sugli utenti, dal momento che per le imprese (anche le Big Tech) l’IVA è un’imposta neutrale, che finanziariamente non influisce su di esse. Altro è se si riuscisse a ricostruire sulla “cessione” dei dati la produzione di un reddito tassabile ad IRES. Qui i vantaggi per gli Stati sarebbero molto elevati, ma – a parte le problematiche che ho segnalato in precedenza in tema di IVA che restano valide anche in questo caso – c’è l’ulteriore questione se il reddito per la multinazionale digitale si colleghi al dato “grezzo” oppure se sia l’effetto della successiva selezione e profilazione, che da un lato può avvenire in uno Stato diverso da quello dell’utente (e quindi il valore aggiunto tassabile si collocherebbe in quell’ordinamento e non in quello dell’utente) e dall’altro fa sì che si possano avere situazioni nelle quali i dati sono conferiti ma magari non sono rilevanti e quindi non danno vita a nessun reddito imponibile».
In parole povere, «l’idea del dato resta vincente nell’ottica della tassazione 4.0 (chiamiamola così), ma richiede un affinamento tutt’altro che banale per poter funzionare in concreto».
«Le Big Tech hanno accumulato senza tassazione, è il momento di ristabilire la gerarchia dei valori»
Si tratta di una considerazione tanto semplice nella sua generazione quanto complessa nella sua attuazione: «Le Big Tech hanno sin qui accumulato enormi ricchezze anche grazie alla sostanziale assenza di imposizione sui loro redditi: è giunto il momento di ristabilire la gerarchia dei valori e chiamare anche questi contribuenti a rendere alla collettività parte di quella ricchezza realizzata anche grazie alle infrastrutture messe a disposizione dei vari Stati. Non se ne deve fare una battaglia politica, ma di diritto. Ed è anche un modo per riaffermare la supremazia del potere pubblico sui tanti poteri privati che in questi anni gli si sono contrapposti».
Pagare le tasse, secondo lo studioso di diritto tributario, non costituirebbe un grande danno per le grandi società tecnologiche: «Del resto, la questione è e resta un’altra: chiunque abbia una forza economica, deve concorrere alle spese pubbliche perché questo è un dovere solidaristico non negoziabile. Lo dice la nostra carta costituzionale ma è insito in ogni forma di società organizzata».
Oltre la Global Tax, difficoltà teoriche e pratiche
Una via da percorrere è, senza ombra di dubbio, quella che prevede un accordo a livello mondiale che, però, è complessissima sia nel concepimento che nella messa a terra. «Come accennavo prima, l’accordo politico del 2021 sulla Global Minimum Tax raggiunto in seno al G20 fatica a trovare attuazione – considera Stefano Dorigo – e alcuni Stati (non l’Italia) l’hanno già attuata sul piano interno. Ma è certo che, se solo alcuni Stati la adottano e altri no, il problema resta perché gli operatori più scaltri troveranno il modo di collocare i redditi negli ordinamenti che rimangono contrari». Per la serie: fatta la legge, trovato l’inganno.
«Occorre, in questo senso, un grande accordo multilaterale, ma i tempi inevitabilmente si allungano, anche per le difficoltà tecniche di questa proposta, estremamente complessa già sul piano teorico, ancor più su quello pratico. Pensiamo a quanto sarà difficile attuarla nelle giurisdizioni meno evolute. L’UE in questo senso, come spesso accade, sembra andare più spedita, abbiamo ora una direttiva che attua la tassazione minima (entro il 31 dicembre 2023), ma resta il problema cui accennavo, cioè quello del rischio competitività del sistema europeo se le altre giurisdizioni (penso agli USA) non attueranno interventi analoghi. Occorre un approccio realmente multilaterale, ma le incognite restano tante», conclude Stefano Dorigo.
Un panorama complessissimo in cui, alla fine dei conti, sono molti di più gli interrogativi che le risposte e che necessità di una rapidità di azione che sembra difficilmente ottenibile.