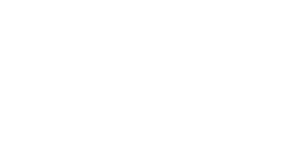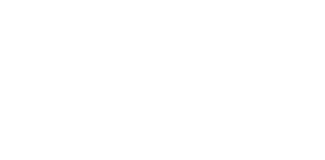I non detti dei quotidiani sul caso We Are Social
Molte testate hanno raccontato quanto trapelato dai social network ospitando, in alcune occasioni, anche interviste. Ma ci sono aspetti che non sono stati approfonditi
23/06/2023 di Redazione Giornalettismo
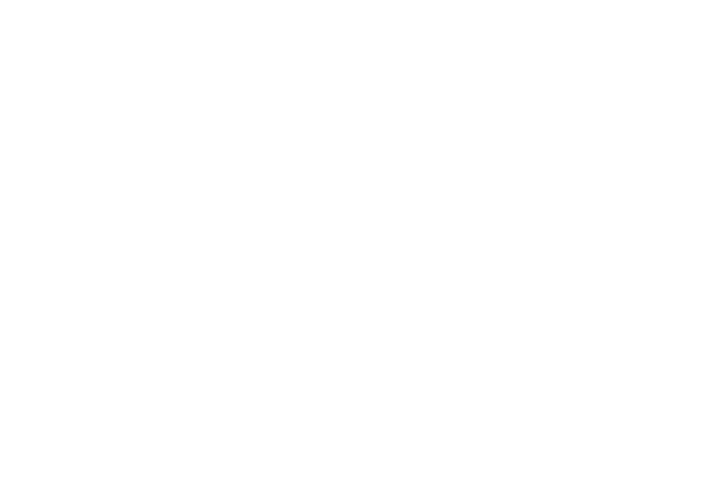
Tutto è nato dai social, o forse no. Il caso delle chat sessiste (e non solo) tra i dipendenti “uomini” di We Are Social è diventato di dominio pubblico nel corso delle ultime due settimane. Tutto è partito da un’intervista rilasciata al profilo social “Monica Rossi” da parte di un pubblicitario e da lì sono iniziate a sopraggiungere – via Instagram – i racconti e le testimonianze di altre donne: sia ex-dipendenti della suddetta agenzia, sia ex lavoratrici di altre agenzie pubblicitarie. Ma nel loro racconto, la stampa – intesa nel senso più esteso del termine – non ha sottolineato alcuni “non detti”.
LEGGI ANCHE > Terremoto nel mondo delle agenzie pubblicitarie: tutto è partito dal profilo IG Taniume
Innanzitutto, partiamo dall’estrema sintesi utilizzata per sintetizzare il fenomeno: “Il me too delle agenzie pubblicitarie”. Questo concetto riprende quel movimento femminista nato e diventato virale sui social – ma anche nelle piazze – nel 2017. Donne che manifestavano – e lo fanno anche oggi – contro le molestie sessuali e le violenze sulle donne. Tutto nacque dopo le accuse di violenza sessuale mosse da più donne nei confronti del produttore cinematografico Harvey Weinstein. Questo parallelismo, dunque, non è del tutto forzato: anche in questo caso, moltissime donne stanno unendo le loro forze per denunciare quel che accadeva – proprio in quegli anni – all’interno dell’agenzia We Are Social: chat esclusivamente maschili (su Skype) in cui i dipendenti si scambiavano (durante gli orari di lavoro) giudizi e commenti di stampo sessista – con riferimenti sessuali – sulle colleghe donne.
We Are Social, come i media hanno coperto la notizia
Ma c’è un mondo online e uno offline. Perché quel che è trapelato dai social è lo specchio di come molti altri episodi simili – come fosse un’orribile normalità – si sarebbero ripetuti all’interno di altre aziende del settore. Sta di fatto che la stampa sta dando un’ampia e giusta copertura a tutto ciò, ma in alcuni casi non vengono sottolineati alcuni aspetti fondamentali. Per esempio, il primo a denunciare pubblicamente il caso della “chat” è stato il famoso pubblicitario Massimo Guastini. Ma non nella sua recente intervista al profilo Facebook “Monica Rossi”. Lui, infatti, sono anni che denuncia casi di molestie sessuali all’interno del suo ambiente di lavoro. E c’è di più. Perché di questa chat – anche se non era stato fatto il nome dell’azienda – si era già parlato nel gennaio 2020, quando il podcast Freegida aveva raccontato dell’esistenza di questo sistema all’interno di We Are Social. Come detto, però, il nome dell’agenzia pubblicitaria non era stato fatto.
La “difesa” dell’azienda
Questo, però, è solo uno dei non detti della narrazione mediatica che è stata fatta di questa vicenda gravissima. E non solo per i contorni. L’altro aspetto, infatti, arriva dalla difesa – a mezzo stampa – da parte dell’azienda. Al netto delle possibili (ma non accertate) responsabilità di chi guida We Are Social, l’intervista rilasciata da Gabriele Cucinella – uno dei tre fondatori – a Prima Comunicazione mostra un aspetto non evidenziato dalle testate. Al netto delle dichiarazioni, infatti, scorrendo lungo l’articolo emerge un passaggio chiave narrato da Emanuele Bruno nel suo incipit:
«Uno dei tre fondatori dell’agenzia, Gabriele Cucinella (attualmente regional lead Eu Area della struttura) il network che era entrato nel racconto di Guastini per la citata ‘chat degli 80’, ha risposto su Facebook all’ex capo di Adci. Ma poi ha voluto raccontare a Prima Comunicazione, assieme al capo delle risorse umane dell’agenzia, Giuliana Piana Caramella, la sua versione dei fatti».
Ed è proprio qui il vulnus della questione: perché Gabriele Cucinella partecipa a un’intervista in “compagnia” della responsabile delle risorse umane dell’agenzia? Una domanda non banale per un motivo fondamentale: un HR (human resources) è sì un dipendente di un’azienda, ma deve porsi in una posizione mediana tra il lavoratore e il datore di lavoro. L’aver partecipato – confermando, di fatto, la tesi del fondatore – alla stessa intervista non è tecnicamente corretto. Inoltre, oltre al fatto che dalle loro parole non emergano riferimenti alle molestie anche “offline” (ovvero il clima non propriamente giusto all’interno delle stanze), ma solo a quella chat. Questi sono aspetti che meritano riferimenti quando si racconta questa triste vicenda che non coinvolge solamente un’azienda, trattandosi – dalla quantità di testimonianze – di un fenomeno (culturalmente digradante) molto diffuso. Anche fuori dalla rete.