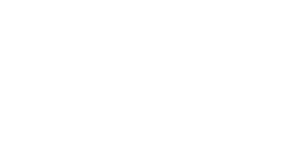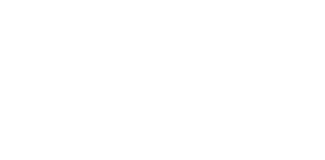Come si risolve il problema degli stereotipi di genere nella pubblicità?
Un dialogo con Giovanna Cosenza, docente dell'università di Bologna specializzata in pubblicità e discriminazione di genere, per capire in che direzione stiamo andando quando si parla di pubblicità e sessismo
26/02/2021 di Ilaria Roncone
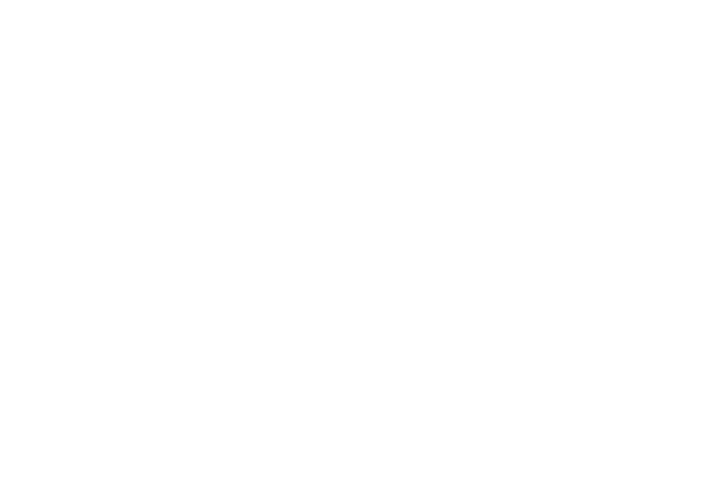
Nonostante sia il 2021 e nonostante la direzione presa dalla società sia quella di creare un sistema sempre più paritario, nel mondo della pubblicità – che siano affissioni, televisione o social – ancora si arranca. Abbiamo deciso di intervistare Giovanna Cosenza, docente ordinaria di Filosofia e Teoria dei linguaggi presso l’Università di Bologna, per fare un approfondimento in questo senso: dove eravamo, dove siamo ora e verso dove stiamo andando quando si parla di pubblicità sessista. Stereotipi di genere dannosi in questo mondo, dai quali posi di genere pubblicità sessista, ce ne sono ancora troppi e per cambiare direzione dobbiamo agire in prima persona.
LEGGI ANCHE >>> Il sessismo abbonda sulla bocca degli stolti
A che punto siamo in ambito pubblicità sessista?
«Sicuramente la situazione è migliorata molto rispetto a quando ho cominciato a occuparmi del problema una decina di anni fa. Esiste un’istituzione, l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP). Dal 1966 ha lavorato in diversi modi ma negli ultimi dieci anni ha ricevuto molte più segnalazioni poiché la sensibilità di consumatrici e consumatori si è alzata. Uomini e donne hanno cominciato a denunciare sempre più campagne pubblicitarie che consideravano offensive per la persona e veicolo di stereotipi di genere. Le più evidenti, volgari e sessiste sono state puntualmente ritirate dallo IAP».
«Si è creato una sorta di circolo virtuoso tale che: maggiore sensibilità di consumatrici e consumatori rispetto a questo argomento, maggiori segnalazioni, maggiore sensibilità dello IAP e maggiori interventi delle imprese. Proprio a partire da questo, un po’ alla volta, le aziende hanno capito che bisognava starci più attenti. Si tratta di autodisciplina, quindi se una campagna viene ritirata chiaramente si perdono soldi: hai già progettato e prodotto la campagna, hai comprato gli spazi – che siano quelli di affissione o i tempi televisivi, poco importa – e se poi viene ritirata sono soldi buttati via»
Questo vale anche per le campagne social?
«Sul social lo IAP si sta muovendo adesso. C’è una sezione dedicata sul sito: diciamo che sono più indietro in tal senso, ma si stanno muovendo. In generale, però, quando c’è un problema riguarda tutta la campagna poiché sono coerenti, integrate».
E veicolate su più mezzi, quindi.
«Esattamente».
Le «sacche di resistenza» nel mondo della pubblicità
«La buona notizia è che, rispetto a dieci anni fa, siamo messi meglio in Italia. Ci sono ancora delle sacche di resistenza: le grandi imprese più difficilmente fanno questo tipo di comunicazione fortemente lesiva della dignità femminile poiché sono proprio i casi più espliciti e evidenti ad essere denunciati e ritirati. Ci sono due aspetti rispetto ai quali è ancora importante tenere alta l’attenzione: da un lato ci sono le piccole imprese, le periferie, la provincia. Ci sono ancora tanti casi di palestre, officine meccaniche, casi in cui la piccola campagna pubblicitaria di affissioni nel paesino X o Y ancora accade, a volte (così come accade anche nelle grandi città, come il caso dell’agenzia immobiliare di Roma Nord di cui vi avevamo parlato n.d.R.).
«Tutte queste situazioni basta inoltrarle allo IAP e lo IAP procede per ritirarle. Si tratta solo di tenere alta l’attenzione. Questo tipo di casi più pesanti, che poi sono quelli sui quali normalmente si registra maggiore attenzione anche da parte dei social media perché è facile: ti arrabbi, ti indigni oppure ci ridi, mi spiego? Creando anche effetti controproducenti perché a volte vengono resuscitate anche campagna che erano state già ritirate. Queste rimangono in rete e le persone, non andando a guardare la data e non andando a guardare che la campagna è già stata ritirata, ancora si indignano. Così facendo, però, restituiamo una seconda, una terza e una quarta vita a campagna che, se le avessimo dimenticate, saremmo stati meglio».
Le campagne ritirate non spariscono comunque mai dalla rete, quindi.
«E come si fa? Ci sarebbe un lavoro enorme da fare dietro, si tratta del cosiddetto diritto all’oblio. Per far sparire tutto andrebbero pagate cifre esorbitanti a delle agenzie che fanno questo appositamente».
La «zona grigia degli stereotipi di genere»
La professoressa Cosenza parla anche di una «zona grigia degli stereotipi di genere, ovvero quei luoghi comuni che sono molto più sfumati e soggetti a interpretazioni che non sempre vedono il ritiro da parte dello IAP. Questo per dire che siamo messi meglio sui casi più espliciti, volgari e smaccati; per il resto c’è ancora molto lavoro da fare».
Perché, ancora oggi, c’è necessità di utilizzare stereotipi di genere facendo così pubblicità sessista?
«Il concetto di stereotipo, entro certi limiti, è indispensabile per il corretto funzionamento della mente umana. Quando gli esseri umani organizzano l’esperienza consolidano alcune caratteristiche e ne tralasciano altre, rendono simili fenomeni diversi. Questa assimilazione è tipica del modo di comprendere il mondo, il formare concetti e categorie, ma quando diventa un’assimilazione esagerata che si protrae troppo nel tempo diventa uno stereotipo. La comunicazione di massa, inevitabilmente, fa leva su stereotipi perché per raggiungere le masse devi veicolare immagini che siano immediatamente riconoscibili e non si può prescindere dagli stereotipi. Nessuno di noi prescinde da un certo grado di stereotipia anche nell’esperienza quotidiana poiché la quantità di cose che conosciamo per esperienza diretta è molto inferiore alla quantità di cose che conosciamo per sentito dire, per esperienza indiretta e quindi – in un certo modo – funzioniamo così».
«La comunicazione di massa, a maggior ragione perché si rivolge a masse di persone, non può fare a meno degli stereotipi. Sugli stereotipi di genere, ovviamente, c’è il problema che contribuiscono a veicolare discriminazione. In generale quando gli stereotipi riguardano le persone lo fanno sempre, che siano donne, minoranze etniche o religiose, gruppi sociali a rischio di discriminazione. Proprio in questi casi gli stereotipi fanno un lavoro che non è buono ed è in questi ambiti che bisogna stare attenti».
Il fatto che le persone denuncino di più, però, vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta e che viene maggiormente premiata la creatività.
«Si, assolutamente. Nel manifesto deontologico dell’Art Directors Club Italiano c’è un punto che ho contribuito io stessa a scrivere, quando è stato pensato e pubblicato, che riguarda proprio gli stereotipi in cui si ammette che l’uso di stereotipi entro una certa misura è indispensabile ma si mette in guardia sul fatto che vadano usati con consapevolezza e controllo e soprattutto anche rompendoli laddove si possa fare qualcosa di innovativo e di creativo».
Come si va oltre gli stereotipi di genere evitando di fare pubblicità sessista?
Come si risolve, quindi, il problema degli stereotipi di genere nell’ambito della pubblicità?
«Occorre puntare a una sempre maggiore consapevolezza da parte delle agenzie di comunicazione e pubblicitarie, una sempre maggiore consapevolezza da parte delle aziende che investono in pubblicità e una sempre maggiore consapevolezza e attenzione da parte di cittadini e cittadine. Non c’è altra strada. Occorre andare in questa direzione sensibilizzando tutti perché le persone possono cominciare a rifiutare questo tipo di esagerazioni stereotipate, soprattutto se non corrispondono più alla realtà che vivono tutti i giorni. Agire così farà in modo che le aziende, sempre più, capiscano che questo tipo di stereotipi non sono graditi al loro pubblico e quel circolo virtuoso di cui parlavamo prima diventerà sempre più preciso».
Secondo lei in quanto tempo potrà succedere?
«Ci diamo altri 10 anni? Ottimisticamente parlando facciamo 10 anni, nel senso che se ampliamo il discorso al sessismo nella società lì la questione è diversa e peggiore. Il World Economic Forum ha fatto una stima di quanti anni ci vorranno perché, anche nei paesi più evoluti, si raggiunga la parità di genere se non si introducono leggi particolari come le quote rosa: 110 anni. Sono tanto criticate, le quote rosa, e non sto dicendo che vadano bene ma sono un male necessario, almeno per un periodo perché così quando le donne cominceranno ad essere di più nei luoghi di potere, nelle aziende e nelle professioni a quel punto le potrai togliere. Un po’come hanno fatto i paesi del Nord Europa. Questo vale per la società ma non per gli stereotipi di genere che, spesso e volentieri, sono le stesse donne a riprodurre».
Siamo anche noi dentro questo circolo vizioso e siamo educate e cresciute in quel modo lì, tanto che alle volte è difficile anche solo rendersi conto che quell’atteggiamento è frutto di uno stereotipo.
«Esattamente. Essendo un pezzetto piccolo, essendo i pubblicitari dei creativi e delle creative dovrebbero usare la testa e – come è scritto nel manifesto deontologico che abbiamo citato – sapere fare il proprio lavoro nel modo migliore».