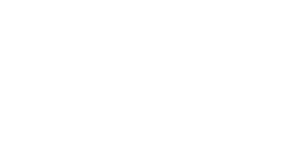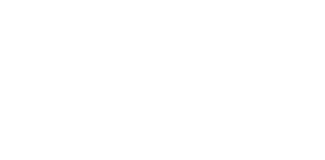Così il digitale ha divorato l’equità: perché si parla di tassa globale e perché potrebbe non essere abbastanza
Al G7 negli scorsi giorni è stato raggiunto un accordo su una “tassa globale” per le multinazionali, rivolto anche ai colossi del digitale, che si mostrano, a sorpresa, favorevoli all’accordo. Ecco perché
13/06/2021 di Daniele Tempera
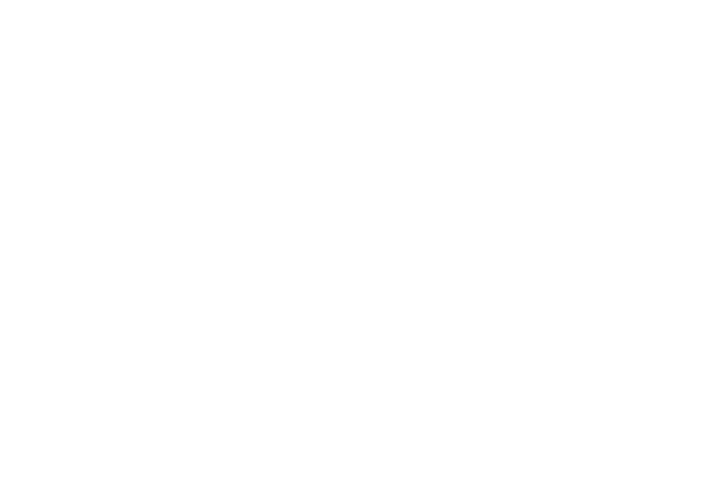
Una catastrofe, ma non per tutti. Se il Covid-19 ha messo alle corde l’economia mondiale, costringendo il mondo intero a una difficile rincorsa verso la “ricostruzione”, i marchi leader del digitale hanno visto lievitare enormemente i loro profitti nell’anno dei lockdown e del distanziamento sociale.
Rimanendo solo agli ultimi trimestri, Apple ha visto aumentare il suo fatturato del 54%, Google addirittura del +162%. Nel corso del 2020 i profitti di Amazon hanno superato invece i 26 miliardi di dollari, più di quelli dei tre anni precedenti messi assieme, mentre i ricavi di Facebook sono aumentati del 20%. Un successo dovuto sicuramente a molti fattori, ma anche a uno spregiudicato equilibrismo fiscale. Basti pensare che nel 2019, l’anno prima del terremoto Covid-19 Google, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb, Uber e Booking.com avevano versato al fisco italiano appena 44 milioni di euro di tasse.
LEGGI ANCHE >>> Cade un tabù: il Parlamento europeo riconosce cinque paradisi fiscali nella UE
A rendere ancora più evidente la contraddizione ci ha pensato uno studio di Mediobanca, uscito nell’ottobre dell’anno scorso. I dati prendono in esame i primi 25 gruppi internet al mondo (Amazon, Alphabet e Microsoft in testa) e ne analizzano ricavi e tasse versate nel corso del 2019 nel nostro Paese. Cifre che fanno riflettere, e non poco.
In Italia le big tech hanno realizzato, nel corso del 2019, profitti pari 3,3 miliardi di euro, ma hanno pagato di fatto appena 70 milioni di euro di imposte. Si va da Amazon che ha versato 10.9 milioni di euro a fronte di un fatturato di 1 miliardo di euro, fino a Netflix che allo stato italiano ha versato nel 2019 6mila euro, meno di quanto possa fare un comune impiegato. Secondo l’analisi le società del digitale hanno risparmiato circa 46 miliardi di euro di tasse, a livello globale, negli ultimi cinque anni. Come è possibile? Semplice molte aziende dell’hi-tech, ma non solo, hanno deciso di spostare le loro sedi legali in luoghi diversi da dove fanno registrare i propri utili, ovvero in veri e propri “paradisi fiscali”. Parliamo di territori a fiscalità nulla (nei casi più estremi) o molto agevolata. No, non dobbiamo pensare necessariamente a isole tropicali. Il Parlamento Europeo ha inserito, non troppo tempo fa, anche nazioni come Irlanda o Paesi Bassi nella lista delle nazioni europee che praticano dumping fiscale a scapito degli altri.
E la presenza di nazioni europee con tassazioni agevolate è stato, in questi anni, forse l’ostacolo più grande alla creazione di una web tax europea, in grado di ristabilire equità e recuperare fondi preziosi che possono tradursi in welfare, sostegno alla ricerca o alle infrastrutture o incentivi alle pari opportunità. La strada è stata percorsa anche da singole nazioni, senza troppa fortuna. Gli stati fanno sempre più fatica a regolamentare un mercato che è sempre più globale e, nel caso del digitale, sempre più immateriale. In Italia la web tax è scattata da poco, dopo numerosi rinvii, portando però entrate fiscali nettamente inferiori alle cifre attese
LEGGI ANCHE >>> La Web Tax non decolla: versati al Fisco italiano solamente 233 milioni di euro
Ed è proprio nel quadro del dissesto pandemico e della grande richiesta di liquidità che si è andata formando la proposta di Janet Yallen, ministra del tesoro dell’amministrazione Biden. Parliamo di un’aliquota minima globale del 15% che tutte le multinazionali sarebbero chiamate a versare, indipendente da dove decidono di stabilire la loro sede fiscale. Se le aziende infatti spostano i loro utili in nazioni con una tassazione inferiore a questa soglia, gli stati dove realmente realizzano i profitti potrebbero richiedere la percentuale mancante. Si tratta sempre di un’imposta di favore, ben al di sotto del 24% per esempio dell’Ires, l’imposta sul reddito pagata dalle piccole e medie imprese italiane e molto al di sotto dell’Irpef versato da un qualsiasi dipendente.
Il secondo pilastro dell’accordo mira invece a far pagare alle multinazionali le tasse nei paesi dove realmente producono la loro ricchezza: le multinazionali con un margine commerciale del 10% dovranno pagare il 20% dei profitti nei paesi dove realmente ottengono gli utili. Una clausola secondo alcuni escluderebbe automaticamente Amazon e che interesserebbe appena un centinaio di multinazionali al mondo.
Complessivamente si tratta di una proposta di accordo al ribasso rispetto al 21% di imponibile ipotizzato inizialmente da Biden, una mediazione realizzata per venire incontro ai paesi con agevolazioni fiscali che promettono comunque battaglia. Gli introiti generati da parte delle singole nazioni inoltre, non sono tali da segnare un’inversione di tendenza. È però indubbio che se venisse confermato dal G20 in programma il prossimo mese, si tratterebbe comunque di un primo esempio di tassa globale sui profitti delle multinazionali, dopo oltre 30 anni di deregulation finanziaria globale. Per le nostre casse dovrebbe tradursi in un introito di poco più di 2 miliardi di euro l’anno. Ma è abbastanza?
Per rendersi conto di come si sono spostati gli assetti in questi anni, basta tenere d’occhio qualche parametro basilare. Secondo Forbes il 2021, mentre gran parte della popolazione faceva i conti con gli effetti più pesanti della pandemia,il numero dei paperoni (https://www.forbes.com/billionaires/), ovvero dei miliardari mondiali, è aumentato di ben 660 unità. L’uomo più ricco del mondo è Jeff Bezos, il patron di Amazon, con un patrimonio di ben 171 miliardi di dollari, seguito da un altro simbolo del nuovo capitalismo digitale, Elon Musk che vanta un patrimonio personale di ben 151 miliardi di dollari. Ma le premesse di una tale polarizzazione vengono da lontano.
Nel 1980 la media mondiale della tassazione sulle corporation ammontava al 40%. Oggi è appena al 23.85%, mentre sono proliferati i paradisi fiscali dove è possibile non versare un solo centesimo sui profitti effettuati in ogni parte del mondo. E se, complici pensiero neoliberale e globalizzazione, l’abbassamento delle tasse alle multinazionali è stata una costante degli ultimi 40 anni, è dal 2000 che questo processo prende letteralmente il volo. Con l’avvento massiccio del digitale, e con la possibilità di muovere capitali e risorse con un click, da una parte all’altra del globo, questa dinamica è proliferata. Così come è proliferata la competizione tra gli stati per attrarre multinazionali e capitali apportando una tassazione di favore. Rimanendo al nostro Paese, l’irpeg (imposta sul reddito delle persone giuridiche) nel 2000 ammontava al 37% . Oggi ha cambiato nome (si chiama Ires) ma è fissata al 24% e si dibatte su come abbassarla ancora per rendere il nostro Paese competitivo nel mondo. Una rincorsa che comporta meno gettito fiscale per tutti che si traduce in meno fondi per ospedali, ricerca, welfare, lotta ai cambiamenti climatici, pari opportunità, riduzione delle disuguaglianze.
Per aspettare se il nuovo progetto di tassa globale verrà preso in considerazione bisognerà attendere almeno un mese e poi, in caso, anni di difficile implementazione.
Nel frattempo cosa ne pensano i grandi delle Big Tech? Google parla di “Accordo bilanciato”, Amazon parla di “multilateralità che va nella direzione giusta”, mentre Nick Clegg, vicepresidente degli affari esterni di Facebook ha dichiarato: “Vogliamo che la riforma della tassazione internazionale abbia successo, e riconosciamo che potrebbe significare un carico fiscale maggiore per Facebook, e in diversi Paesi”. Insomma, le multinazionali che dovrebbero essere il maggiore bersaglio della nuova imposta sembrano tra i soggetti più favorevoli all’accordo.
Per molti le tasse si scaricheranno automaticamente sugli utenti, mentre resta critico un economista come Pinketty che osserva: “Dare alle grandi multinazionali il privilegio di pagare il 15% di tasse significa riconoscere loro il diritto di pagare meno di quanto non debbano fare le piccole e medie imprese, come del resto la maggior parte delle persone e in generale la classe media”. Segno che la montagna ha forse partorito il topolino e la “rivoluzione”, per il momento, può aspettare.