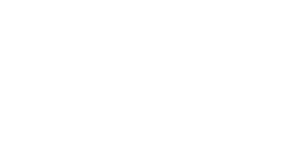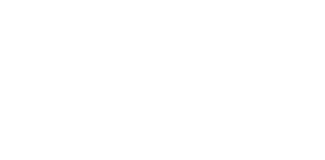Guerre di religione dei giorni nostri
08/11/2012 di Alberto Sofia
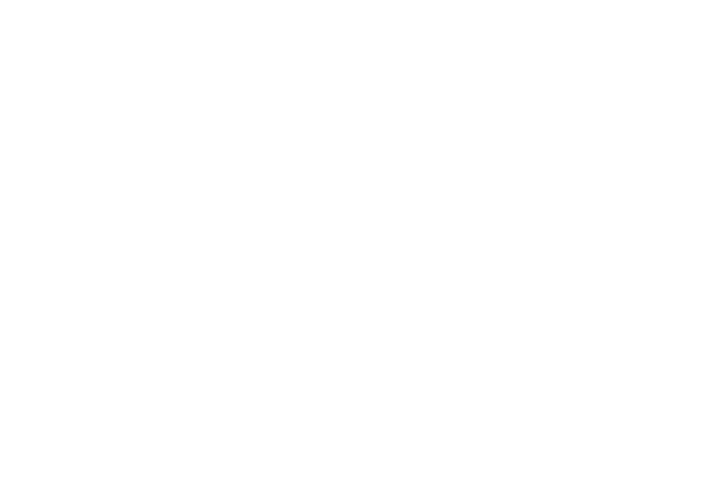
Le guerre di religione non sono certo una novità nella storia. Così come gli scontri tra gruppi ed etnie, soprattutto nei paesi dove regimi autoritari tendono a reprimere nel sangue le rivendicazioni delle minoranze. Ma il conflitto da tempo in corso in Birmania, tra i buddisti e la minoranza musulmana di etnia Rohingya sta assumendo i contorni di una vera e propria faida. Uno scontro sanguinario ripreso nelle ultime settimane in modo così feroce da spingere le Nazioni Unite a lanciare un appello alle autorità birmane, per richiedere “l’accesso immediato e incondizionato a tutte le comunità che vivono nella zona”, così come previsto dai principi umanitari.
LE VIOLENZE – Teatro delle persecuzioni religiose nei confronti dei musulmani è soprattutto lo Stato del Rakhine, nell’ovest del paese, al confine con il Bangladesh del Nord. In quest’area nelle ultime settimane sono riprese le violenze contro quella minoranza apolide già da tempo considerata dall’Onu una delle più perseguitate al mondo. Secondo quanto riportato da diversi media – tra i quali The Economist – numerose sarebbero le vittime dei disordini. Il governo ha parlato di 82 persone rimaste uccise, ma soprattutto di circa 4.600 case bruciate. Senza contare gli oltre 22.000 sfollati. Ma sono cifre sicuramente sottostimate. Alcune immagini satellitari hanno mostrato la completa distruzione di un quartiere musulmano della città costiera di Kyaukphyu, ovvero il centro da dove gli oleodotti di petrolio e di gas attraverseranno il Myanmar per arrivare fino in Cina, a Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan. Un collegamento strategico che sarà pronto entro il 2015.
LA REPRESSIONE – Nonostante le autorità del Paese a maggioranza buddista non riconoscano loro la cittadinanza, i musulmani continuano ad arrivare dal vicino Bangladesh, dove circa 300mila rohingya vivono nei campi profughi. Molti abitanti erano già fuggiti via mare verso la capitale dello stato, Sittwe. Così il conflitto etnico è subito ripreso: molti sono stati confinati dallo scorso giugno in squallidi campi, dopo la ripresa del conflitto in seguito allo stupro e all’omicidio di una donna buddista. Intanto, le autorità hanno imposto lo stato di emergenza. Da allora Sittwe è sotto coprifuoco, così come molti centri del Rakhine. Non pochi hanno accusato il governo centrale di alimentare la violenza: alcuni ministri, invece di stemperare la tensione tra i gruppi religiosi, hanno rilasciato dichiarazioni incendiarie. Forse strumentalmente: l’obiettivo, secondo molti, era quello di far deragliare le riforme democratiche del Myanmar. Non sarebbe la prima volta: la necessità di contenere i conflitti etnici e il separatismo sono stati un mezzo a lungo utilizzato per giustificare la dittatura dell’esercito durata ben 50 anni.
LEGGI ANCHE – Fiumi di sangue in Myanmar
RIVOLUZIONE TRADITA? – Eppure la trasformazione politica della Birmania, dopo la vittoria del partito della storica eroina dell’opposizione Aung San Suu Kyi (per anni confinata in carcere dall’esercito , prima di essere ammessa nel 2012 alle elezioni, ndr), aveva aperto le speranze per una pacificazione del paese, abitato da diverse etnie. Sembrava una rivoluzione senza perdenti quella che aveva portato al trionfo dell’NDL dell’ex premio nobel birmano. Ma era soltanto un’illusione: questo perché l’esercito, che aveva brutalizzato il paese per mezzo secolo, è rimasto praticamente impunito, oltre a mantenere influenza nel paese. Certo, centinaia di prigionieri politici sono stati liberati e l’azione dell’ex leader dell’opposizione Aung San Suu Kyi è riuscita ad emergere. Ma un gruppo è uscito terribilmente sconfitto, ovvero proprio quello della minoranza musulmana. Che continua ad essere perseguitata: certo non è stata in passato esente dalla responsabilità di alcune violenze, ma ora rischia di essere vittima di una campagna feroce e sanguinosa di pulizia etnica.
I SILENZI COLPEVOLI – Diversi politici del Rakhine hanno affermato che l’unica alternativa alla deportazione di massa sia una forma di apartheid birmano, come confermano gli squallidi campi profughi creati in tutta la regione. Così l’unica speranza può essere un intervento dell’unica persona in Myanmar che dispone di una vera autorità morale, la stessa San Suu Kyi. Per ora però l’ex premio nobel si è limitata a chiedere il rispetto dello Stato di diritto. Ma serve un maggiore impegno: questo perché, come sottolinea l’Economist, è necessario alzare la voce contro una la legge ingiusta e ingiustamente applicata. La stessa che un tempo la vedeva come principale vittima: “Un suo disinteresse sarebbe un tradimento degli alti principi morali che ha sempre sposato“, conclude il quotidiano.
I MONACI – Pesa il silenzio di chi fino a poco tempo fa non vedeva riconosciuto alcun diritto dalla dittatura militare. La Stampa del 4 settembre riportava: “In Birmania i monaci buddisti sono tornati a protestare, con un lungo corteo color zafferano come quello della rivoluzione del 2007 repressa nel sangue”. Ma se fino a poco tempo fa l’obiettivo era marciare contro la giunta militare, per chiedere la tutela dei propri diritti, oggi i monaci sono diventati sostenitori attivi della politica del neopresidente. Che non è altro che un ex generale. “Il nemico comune sembrano diventati gli 800 mila musulmani di etnia Rohingya nell’ovest”, si legge. Contro questa minoranza di “diversi” sembra essersi compattata la nuova Birmania: una situazione paradossale e impensabile fino a un paio di anni fa. E che rischia di far implodere subito il tentativo di rinascita democratica del paese.
(Photo-video credit: Lapresse e The Economist)
LEGGI ANCHE: