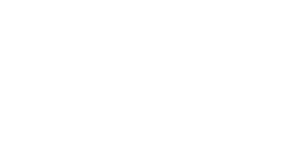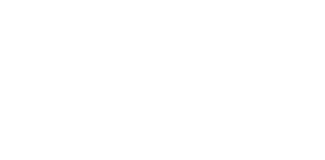La Corte Suprema australiana ha ribaltato la sentenza di condanna contro Google per diffamazione
Un caso datato 2004 è arrivato al suo capitolo finale: nonostante sia stata data "vetrina" a un articolo ritenuto diffamatorio, l'azienda Big Tech non è ritenuta responsabile
17/08/2022 di Enzo Boldi
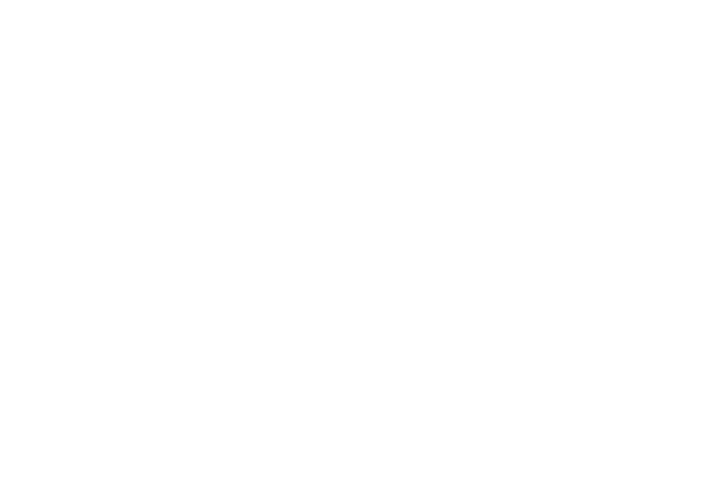
In questa fase storica, una sentenza come quella pronunciata dalla Corte Suprema australiana ha un peso specifico notevole. Perché nonostante la legislazione di molti Paesi stia tentando di etichettare le piattaforme Big Tech (come Google e Meta) come veri e propri “editori” per quel che riguarda gli articoli ospitati nelle loro “vetrine” o bacheche, la decisione dei giudici dell’Australia ribalta in toto questa indicazione. Questa svolta arriva nel merito di una causa iniziata addirittura nel 2016 e faceva riferimento a un articolo comparso nel web nel 2004.
LEGGI ANCHE > Cos’è questo diritto alla buona fama che verrà chiesto ai giornalisti: è inserito nel programma di centro-destra
Ripercorriamo tutte le tappe di questa controversia prima di arrivare alle motivazioni e agli effetti presenti, futuri e futuribili che deriveranno da questa sentenza. Era il 2016, quando l’avvocato George Defteros fece una ricerca su Google e trovò un articolo del 2004 in cui veniva accusato, come riporta ABC News, di «di cospirazione e incitamento all’omicidio di figure della malavita». Accuse che erano state mosse contro di lui, ma che vennero ritirate l’anno seguente. Vista, però, la persistenza di quell’articolo all’interno del motore di ricerca, il legale ne chiese la rimozione. Ma nel 2020 arrivò la risposta negativa a questa richiesta e allora lo stesso avvocato australiano decise di denunciare Alphabet Inc. per diffamazione.
Inizialmente un tribunale statale australiano – la Corte Suprema di Victoria – gli diede ragione, obbligando l’azienda Big Tech al risarcimento danni nei confronti dell’avvocato. Insomma, secondo i giudici Google è a tutti gli effetti un editore e dunque ha responsabilità anche legali sugli articoli presenti all’interno della sua “vetrina”. Era il 2020, quindi, e un tribunale aveva riconosciuto un ruolo ben definito per Google e per le altre aziende digitali che ospitano articoli. Una versione dei fatti che era stata contestata dall’azienda che aveva impugnato la sentenza.
Google non può essere condannata per diffamazione
Poi la decisione, arrivata nelle scorse ore, da parte della Corte Suprema Australiana, il massimo organismo giuridico all’interno del Paese, ha ribaltato tutto ciò. Con le seguenti motivazioni: «L’articolo di Underworld (la testata in cui era apparso quel pezzo ritenuto diffamatorio, ndr) non è stato scritto da alcun dipendente o agente del ricorrente (Google, ndr). È stato scritto da un giornalista senza alcun legame con il ricorrente e pubblicato da un quotidiano indipendente sul quale il ricorrente non aveva alcun controllo o influenza. Fornire un collegamento ipertestuale tra i risultati della ricerca ha semplicemente facilitato l’accesso all’articolo. Ma non c’è stato alcun atto di partecipazione al processo bilaterale di comunicazione del contenuto di tale articolo a una terza parte». Il motore di ricerca, dunque, non è un editore di contenuti. Ma si limita a ospitarli. E, dunque, non ha alcuna responsabilità per quel che riguarda presunti ed eventuali reati commessi da un giornalista (e non solo) o da una testata. Google, dunque, non è un editore.