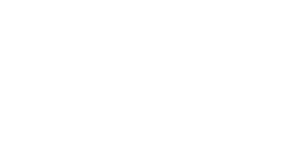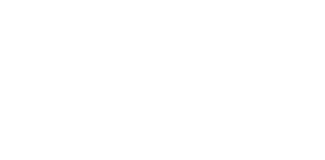L’evoluzione (o l’involuzione) del contenuto giornalistico su Facebook
C'era un tempo in cui la vetrina social era il simbolo del successo. Poi, tutto è andato perduto
24/04/2023 di Enzo Boldi
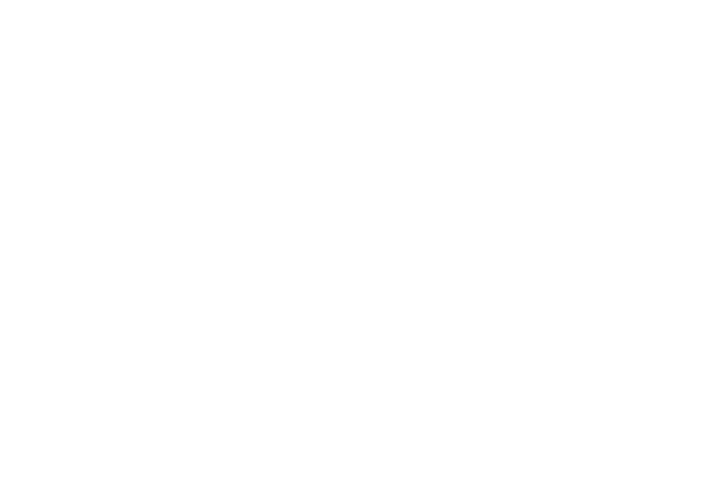
C’era un tempo in cui i social erano “innamorate” dei contenuti giornalistici e i giornali ricambiavano questo sentimento profondo. Erano gli inizi, quando queste nuove piattaforme digitali riuscivano a fornire una grande e ampia vetrina agli articoli che raccontavano storie di cronaca, politica, economia e sport. Persone che condividevano con i propri “amici” un contenuto rispetto a un altro. Dunque, l’inizio del matrimonio tra il giornalismo e Facebook è stato costellato di luci e pochissime ombre. Ma la luna di miele, dopo anni di convivenza forzata, si è esaurita nel corso dell’ultimo lustro.
LEGGI ANCHE > Lo “strano” progetto imprenditoriale che aveva portato alla nascita di BuzzFeed News
Partiamo dalle origini. Pochi anni dopo la sua creazione – nata dall’idea di Mark Zuckerberg -, sulla piattaforma venne inserita la possibilità di condividere link di terze parti. Questo aspetto rappresentò il primo vagito dell’informazione pubblicata anche attraverso i social network. Il feed (quello che si chiamava timeline) mostrava tutti contenuti condivisi dagli “amici” o dalle pagine che si seguivano. Tutti, indiscriminatamente. Poi, però, con il passare del tempo più di qualcosa è cambiato.
Giornalismo su Facebook, storia di una mancata evoluzione
All’inizio, dunque, i blog (attraverso la possibilità di creare pagine pubbliche e condividere i link, funzionalità estesa anche ai gruppi a partire dal 2011) ottennero una grandissima vetrina: migliaia di persone che avevano un proprio progetto personale online, utilizzavano Facebook come vetrina. Non c’era ancora un algoritmo così “potente” in grado di orientare quelli che oggi potremmo definire come i “contenuti suggeriti” e, dunque, anche i principali siti di informazione giornalistica trassero un notevole vantaggio da quelle che sembrava essere un’opportunità a un costo tangibile pari a zero.
Tutto ciò, però, ha dato una grande spinta a quello che è diventato monopolizzante: sempre più realtà giornalistiche iniziarono a seguire i trend, portando a un deperimento della qualità dell’informazione. Facebook, infatti, forniva ai giornalisti piattaforma senza confini per raggiungere un pubblico vasto e variegato. Una sorta di “Catena di Sant’Antonio” per l’informazione che, ovviamente, aveva anche dei lati oscuri: questa dinamica non ha fatto altro che portare alla diffusione di fake news. E mentre i giornali avevano deciso di virare verso la strada del “click a tutti i costi”, ecco che Facebook ha intensificato il ruolo del suo algoritmo mutevole (di cui si conosce poco, se non gli effetti).
La dipendenza
Il link ha sempre più perso valore (economico e commerciale), unito ai minori introiti pubblicitari provocati dalla concorrenza (perché il giornalismo su Facebook ha dovuto fare i conti anche con tutte le altre piattaforme che, con tempi e modi diversi, si sono palesate sul “mercato”). E quell’effimera possibilità di usare i social network come contributo all’audience totale ha avuto effetti mortiferi sull’informazione. Non solo sulla qualità, ma soprattutto sulla dipendenza. Avere una vetrina a costo praticamente azzerato, ha provocato una serie di scossoni a catena: il mondo dell’informazione ha perso sempre più i suoi princìpi andando a ricercare “click” con titoli talmente accattivanti dal non sintetizzare il reale contenuto di un articolo. Dunque, il “link” è diventato ostaggio del titolo. Il tutto mentre l’algoritmo iniziava a decidere quale contenuto premiare (e non per autorevolezza della “testata”, ma per tematiche) rispetto a un altro. Dunque, viziando inevitabilmente anche la percezione dell’utente rispetto alla gerarchia delle notizie.
Il giornalismo, però, non è stato solamente vittima di questo sistema. Scegliendo arbitrariamente di sottostare a queste regole non trasparenti, ha fagocitato questa dinamica. Forse anche illuso da Facebook (prima, poi anche dalle altre piattaforme) che sembrava aver messo l’informazione al centro delle funzionalità del social network. Basti pensare al programma Instant Articles (che ricalca, come strumento, quello degli AMP su Google), annunciato come una sorta di “premio” per i contenuti migliori e, alla fine, rivelatosi come uno specchietto per le allodole (e in procinto di chiudere).
In tutto questo si innestano le polemiche sul ruolo di “editore” di Facebook. Perché le norme sull’equo compenso agli editori per i contenuti condivisi sul social network è stato l’elemento principe del definitivo scollamento tra il mondo dell’informazione (già viziata) e la piattaforma. Le diatribe con Australia e Canada, la sparizione delle immagini nei link condivisi di articoli giornalistici, la dismissione del settore news e l’algoritmo hanno fatto il resto. A oggi, infatti, il traffico social per quel che riguarda i contenuti di giornalismo su Facebook è praticamente pari a zero. Non contano più il numero di follower (o fan), ma c’è un algoritmo che decide la rilevanza data a un contenuto. Dunque, il giornalismo che ha inseguito per anni i trend ha – di fatto – perso la propria anima e ora non sembra essere in grado di reagire, mandando in fumo investimenti, chiudendo realtà (come nel caso di BuzzFeed News) e lasciando a casa persone che da anni lavorano in questo mondo.
I risvolti a livello di qualità
Come detto, però, la vittima (il giornalismo) si è messa nelle condizioni di dipendenza nei confronti di questo che è diventato un modello di business. Da anni il giornalismo su Facebook vive all’interno di una bolla. Una sorta di sindrome di Stoccolma: consapevole di vivere ingabbiato in delle regole (tra l’altro non meglio definite) esterne, ha preferito cedere a tutto ciò per portare a casa quanti più soldi (metricamente misurabili nei click) per la propria sopravvivenza. Pochissimi gli esempi di una reazione a questo “sequestro”, soprattutto provenienti da piccole realtà. E così abbiamo assistito alla trasformazione di realtà editoriali nate seguendo lo spirito della denuncia del malcostume politico-economico, in laboratori di click-baiting.
Notizie importanti – che meriterebbero approfondimenti – messe in secondo piano (o lasciate a realtà editoriali che hanno deciso di puntare sulla qualità e non sul click, pur sapendo il rischio imprenditoriale di questa scelta che sembra essere “fuori dal tempo) per dare spazio a tutto ciò che oggi vediamo scorrendo lungo il nostro feed su Facebook, dove l’algoritmo decide cosa mostrare “in base alle nostre preferenze” (dicono). Dunque, notizie “leggere” (con il gossip che continua a essere grande protagonista), curiosità, stranezze. Contenuti che poco hanno a che vedere con il mondo dell’informazione. E con il cambio dei temi si è abbassata anche la qualità di come vengono raccontare le storie: riprese dai social, articoli basati sui commenti pubblicati sui social. Dunque: non più social che “riportano” cosa dicono i giornali, ma giornali che “riportano” quel che viene detto e scritto sui social. E non solo. Perché il link ha perso di valore e, dunque, il giornalismo su Facebook ha deciso di seguire le altre regole non scritte (almeno non chiaramente) della piattaforma: il “testo” è superato, puntate sui video (con annesso sbarco dei reels in stile Instagram). Il segnale arrivato da Menlo Park, dunque, era piuttosto chiaro: basta con i contenuti esterni (quelli di terze parti) per dare spazio a contenuti video in grado di alimentare solo ed esclusivamente la piattaforma (in modo nativo).
Giornalismo su Facebook, è rimasta solo la buccia
L’effetto, dunque, è stato devastante. Per anni il mondo del giornalismo (e dell’informazione, nel senso più esteso del termine) ha pensato di aver trovato la propria strada verso la condivisione del suo percorso di digitalizzazione. Ha affidato a Facebook (in primis) le proprie sorti, sottovalutandone le conseguenza. Sia in termini meramente “commerciali” (pensando di sopperire così al continuo de profundis che suona per quel che riguarda il giornalismo cartaceo), che in termini di qualità. Perché se l’algoritmo “decide” di premiare un articolo di gossip sul divorzio di due vip rispetto a un reportage sul golpe di Sudan, sempre più testate metteranno da parte il loro intento di “informare” i cittadini-lettori su fatti reali (con conseguenze sulle vite degli esseri umani) per parlare dei rumors del momento.
Un’equazione terrificante per il mondo dell’informazione che crede di essere alimentato da quello stesso sistema che – da oltre cinque anni, perché il 2018 può essere indicato come la data dell’inizio delle evidenze del peso specifico delle aziende Big Tech anche sui percorsi decisionali – lo ha affamato. Colpa di tanti. Colpa di tutti. Ma è così che il giornalismo ha deciso di condannare se stesso a un ruolo di effimero strumento per la condivisione di notizie non decise in base ai criteri di “notiziabilità“. Perché gli interessi dell’utente non sono “sinceri”, ma viziati da quel che l’algoritmo decide di mostrare. Un tempo si era inconsapevoli di questo, ma poi ci si è risvegliati da questo incubo. Senza la forza di reagire.