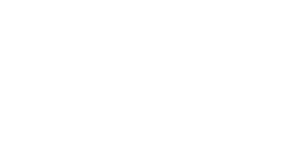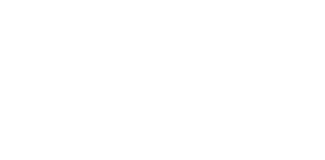Il parere degli avvocati sul caso di We Are Social
Abbiamo contattato due avvocati, Valentina Fiorenza e Davide Biondini, per provare a inquadrare a livello normativo la vicenda della chat Skype di We Are Social
23/06/2023 di Ilaria Roncone
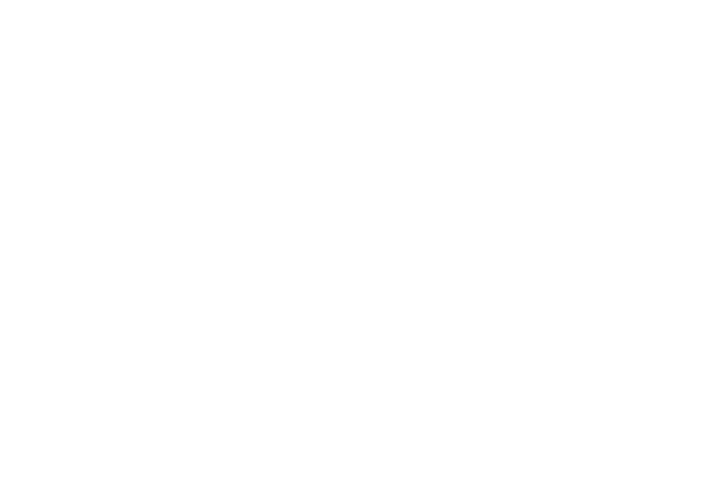
Nella giornata di oggi abbiamo provato a inquadrare la vicenda di We Are Social dal punto di vista giuridico, rispetto alle testimonianze emerse finora, facendo una serie di ipotesi. Per farlo abbiamo contattato due professionisti del digitale in ambito giuridico: l’avvocata Valentina Fiorenza e l’avvocato Davide Biondini.
Con entrambi siamo partiti da un presupposto preciso: quali siano gli estremi per procedere nel caso di We Are Social, a questo punto, è ancora difficile dirlo. A dirlo sono stati entrambi i professionisti, e quindi – lo chiariamo a scanso di equivoci – ci stiamo muovendo solo nell’ambito dell’ipotesi, basandoci sugli elementi che sono emersi finora e sulle testimonianze del caso della chat Skype dell’agenzia We Are Social. Con i professionisti abbiamo provato a capire se ci sono e quali siano i riferimenti normativi con cui si può provare a regolamentare e inquadrare una situazione del genere.
LEGGI ANCHE >>> Dai commenti su Skype alle molestie offline: le modalità della chat We Are Social
Caso We Are Social, l’analisi degli avvocati
Partiamo dicendo che entrambi i professionisti sono concordi collocare – sulla base delle modalità emerse finora dalle testimonianza diffuse via social (chat di lavoro Skype utilizzata per fare commenti e battute oscene in orari lavorativi) – la vicenda all’interno di una serie di articoli. In Italia, in un caso come questo, ci sono diverse norme alle quali poter fare riferimento.
Il parere dell’avvocata Valentina Fiorenza
«Si tratta di una circostanza piuttosto agghiacciante – ha affermato la professionista ai microfoni di Giornalettismo -. Sappiamo bene che ci sono certe situazione che sono un limite ma, ahimè, il vulnus è culturale. La possibilità di inquadrare una responsabilità dell’azienda c’è eccome, nel senso che parliamo chiaramente di responsabilità civilistica e non penalistica – che è personale -. C’è la norma del Codice civile numero 2087 sulla tutela della condizioni di lavoro per cui l’imprenditore, tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
«Allora questa norma, sostanzialmente, è stata usata per gli infortuni sul lavoro, tuttavia si può benissimo aprire – perché parliamo di tutelare l’integrità fisica, ma anche la personalità morale – per tutte quelle ipotesi, ad esempio, di mobbing o molestie sul lavoro. L’imprenditore è tenuto, giuridicamente, a tutelare il lavoratore e se non lo fa potrebbe essere questo il caso. Poi, ovviamente, bisogna vedere dalle risultanze istruttorie e non dalle notizie che abbiamo o da indiscrezioni varie».
«I reati che sono strettamente configurabili, nel caso di specie, sono la diffamazione – perché, appunto, è possibile che i soggetti siano stati diffamati – oppure, ancora, potrebbero esserci ipotesi di revenge porn – nel caso in cui, ipoteticamente, siano state condivise delle foto. Sempre per ipotesi, magari c’era stata una relazione tra uno di questi uomini e una collega e lui ha diffuso delle foto intime all’interno di una chat. Oppure, ancora, si potrebbe avere la creazione e la diffusione di deepfake e anche lì abbiamo integrata la diffamazione».
«Certamente ci sono norme di natura, da un lato, penalistica e dall’altro abbiamo delle possibilità per un lavoratore che subisca delle molestie all’interno del proprio ambiente di lavoro come le tutele giuslavoristiche, il Codice delle pari opportunità (dl 198 del 2006) per cui, appunto, chiunque subisca delle molestie o discriminazioni può adire il giudice del lavoro cercando di ottenere – in base alla prova che il lavoratore riesce a fornire – sia un’inibitoria del comportamento sia un risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale. Ed è importante ricordare, in base alla norma, che il lavoratore che abbia subito questi comportamenti non possa essere né licenziato né demansionato, insomma: ci sono particolari tutele per questo soggetto, per proteggerlo nella sua attività di difesa dei suoi diritti».
La chat Skype utilizzata in questo modo durante gli orari lavorativi, può essere un’aggravante in sede di giudizio per quanto riguarda le dirigenze? «Dipende dal tipo di organizzazione interna: se avevamo, ipoteticamente, un regolamento interno che specificava: “guarda che la chat Skype puoi usarla solo per lavoro, se la usi per i fatti tuoi durante l’orario di lavoro stai compiendo un illecito disciplinare”, era stabilito cosa è contrario a ciò che dice l’azienda. In questo caso sarebbe un illecito civile del lavoratore nei confronti dell’azienda. Diversamente, non ci vedo un aggravante o nulla nell’utilizzo di questa chat nell’ambito della responsabilità nei confronti delle vittime di questi atteggiamenti».
Il parere dell’avvocato Davide Biondini
«Dagli elementi emersi finora – ha spiegato Biondini a Giornalettismo – qualcosa si ricava, ma non sono sufficienti. Skype è il mezzo con il quale è stata attuata questa molestia ma, in realtà, la fattispecie può essere inquadrabile nell’ambito della molestia generale sui luoghi di lavoro. Ripercorrendo la normativa a volo di uccello rispetto a quelle fattispecie, da un punto di vista civilistico e penalistico riesco ad andare un po’ più in profondità».
«Dal punto di vista normativo non c’è un vuoto, anzi, c’è una pluralità di norme e questo potrebbe creare difficoltà interpretative. C’è stata infatti, un’emorragia legislativa sia a livello europeo che a livello nazionale, e la fattispecie viene regolamentata da diversi punti di vista. Innanzitutto bisogna capire come può essere inquadrata: è una violenza, è una molestia, è una discriminazione diretta o una discriminazione indiretta. Conta anche chi lo ha fatto, se ad esempio è un diretto superiore che può indurre la persona a fare o tollerare qualcosa».
«Da un punto di vista sovranazionale le normative sono davvero infinite, nel senso che partiamo da una direttiva europea del 2002 che regolamenta le molestie come comportamenti indesiderati che non hanno necessariamente connotazione sessuale alle molestie sessuali vere e proprie; ci sono una pletora di raccomandazioni, accordi quadro e quant’altro; ci sono convenzioni europee tra diversi Paesi. La normativa è davvero ampia, poi tra queste normative – salvo che sia un regolamento, quindi a diretta applicazione in Italia – ci sono direttive, accordi quadro, convenzioni, raccomandazioni che vengono ratificate a livello nazionale o in qualche modo assorbite attraverso delle leggi interne».
«E anche in Italia ce ne sono diverse: partiamo, per una responsabilità civile, dall’articolo 2087 del Codice civile che è un generale obbligo di sicurezza sul lavoro che il datore di lavoro – nel caso specifico dell’episodio di cui parliamo, i soci – ha anche rispetto a comportamenti di altri a un decreto legislativo che è il 165 del 2001, che riguarda il lavoro delle donne nella Pa e i percorsi di protezione delle lavoratrici vittime di molestia o violenze (anche se non è questo il caso specifico, poiché siamo nel privato). C’è anche il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che sancisce un’equiparazione tra molestie sessuali e discriminazione di genere, quindi qui si va nel campo del diritto discriminatorio. C’è il decreto legislativo, l’81 del 2008, in materia di salute e sicurezza del lavoro e l’articolo 28 assorbe il 2087 e quindi poi lo estende anche a quel tipo di fattispecie».
«A livello penalistico, poi, il 612-bis che è stato introdotto dalla l. 38/2009, e poi modificata dal Codice Rosso (legge 69/2019) che disciplina gli atti persecutori. C’è la molestia vera e propria che è regolamentata dall’articolo 660 del Codice penale e la minaccia regolamentata dall’art. 612 cp. Potrebbe esserci addirittura la violenza sessuale ex art 609bis».
«In conclusione, non esiste una fattispecie penale che regolamenta la violenza di genere o sessuale sul luogo di lavoro. Cosa ha fatto la giurisprudenza? Ha inquadrato, a seconda delle modalità e della gravità della fattispecie, in uno o nell’altro ambito: in un caso può essere molestia, in un altro caso è violenza sessuale più o meno lieve, in un altro ancora è violenza privata o minaccia, dipende dalla fattispecie concreta e quindi dalle modalità della condotta. Il datore di lavoro non sapeva niente e la molestia sessuale è stata fatta da superiori gerarchici? Potrebbe esserci una responsabilità civile perché c’è, appunto, il 2087 del Codice civile che dice che va garantita la sicurezza sul lavoro, dell’ambiente, dello stato psicofisico e della salute della persona. Se non lo fai, da datore di lavoro, questa è una mancanza».
«Ci possono essere delle responsabilità oggettive del datore di lavoro che, in qualche modo, non ha sorvegliato rispetto al fatto che all’interno degli orari di lavoro si facciano le cose come devono essere fatte. Per sfociare nel penale, ci deve essere qualcosa di più: essere venuti a conoscenza del reato e non avere fatto, successivamente, nulla successivamente. Se, venuti a conoscenza del fatto, l’attività è cessata e non si è più verificata, il fatto che poi altri soggetti abbiano fatto carriera non lo vedo come elemento così importante da giustificare una responsabilità penale, sicuramente una civile».
Per concludere, quindi, secondo entrambi i professionisti pur dicendo “non lo sapevo”, secondo l’articolo 2087 del Codice civile può comunque essere rilevata una mancanza a livello civile perché il datore di lavoro deve occuparsi del benessere psicofisico dei dipendenti.