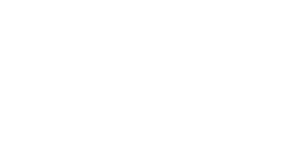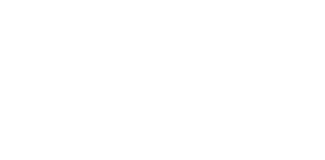«Laureato e specializzato in Italia, ecco perché faccio il medico a Londra»
L’intervista a Pietro Arina, medico specializzato in anestesia e terapia intensiva che ha lasciato l’Italia per lavorare nella Sanità britannica
06/05/2024 di Redazione Giornalettismo
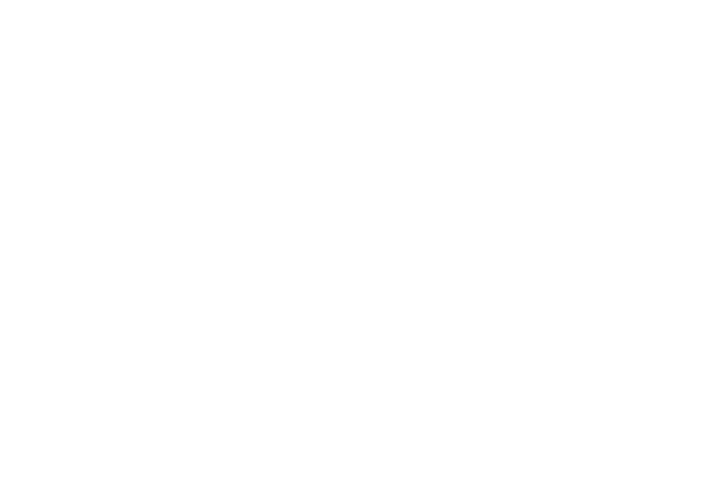
L’abbandono. A volte della professione, a volte del settore pubblico per passare a quello privato. A volte, invece, l’abbandono della propria casa e della propria famiglia per vedere riconosciuta la propria formazione e raggiungere una qualità della vita migliore rispetto a quella offerta dal nostro Paese. Sono tante le storie dei medici che lasciano l’Italia per andare a cercare (e trovare, in molti casi) fortuna all’estero. La chiamano “fuga dei camici bianchi”. I motivi di questi allontanamenti sono molti. C’è chi lo fa perché sente di non avere un’adeguata tutela legale per possibili contenziosi. Chi lo fa perché sente che la professione medica non sia adeguatamente retribuita. Tra le tante storie di medici che hanno studiato e si sono specializzati in Italia, ma ora vivono e lavorano all’estero, abbiamo raccolto la testimonianza del dottor Pietro Arina.
LEGGI ANCHE > Sempre più giovani medici italiani abbandonano la professione
«Sono un medico specializzato in anestesia e terapia intensiva. Ho studiato per tutti i sei anni di medicina a Torino, poi ho fatto la Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Un’ottima scuola da un punto di vista dell’insegnamento perché mi ha reso un medico bravo, ma una delle peggiori esperienze della mia vita che mai più rifarei dal punto di vista umano». Sulla descrizione di questa lunga esperienza, torneremo più tardi. Ma si tratta della descrizione di quei sintomi che mostrano come sia il sistema a essere fallace su molti fronti.
Pietro Arina, il giovane medico che ha lasciato l’Italia
La carriera professionale di Pietro Arina è, ora, nel Regno Unito. Oggi ha 35 anni, ma si è traferito a Londra dopo aver lavorato a un progetto di ricerca che non aveva ottenuto una grande attenzione in Italia: «Ho sempre fatto ricerca. Quando la facevo in Italia, dovevo dedicarmici durante il tempo libero, finiti i turni di lavoro. Però io un po’ ci credevo e grazie a una ricerca che avevo fatto e che avevo presentato a un convegno all’estero, fui avvicinato da vari professori che dicevano: “Vuoi venire a fare un’esperienza all’estero?”. Lì ho visto la prima differenza, per questo ho incontrato il mio attuale professore, Mervyn Singer, il “Ronaldo” della terapia intensiva. Nel 2018 mi ha proposto di trasferirmi. L’anno successivo, a Londra, ho iniziato un percorso di esperimenti per un progetto e che è terminato il giorno prima del lockdown. Il giorno seguente, ho iniziato a lavorare nel reparto di terapia intensiva».
Un reparto sollecitato, per usare un eufemismo, durante la pandemia Covid-19. Il lavoro si è moltiplicato, così come la necessità di essere sempre più spesso chiamato a soccorrere persone in emergenza. Parallelamente al suo lavoro, però, è riuscito a ottimizzare i tempi, potendo dedicarsi ad altri approfondimenti: «Londra mi piace, l’ambiente è interessante e sono rimasto. Ho iniziato un dottorato in intelligenza artificiale applicata alla medicina, presso la University College London. Poi ho lavorato fra gli ospedali pubblici, che qua fanno parte del NHS, National Health Service, e il privato. Come spesso accade, quando una persona fa un dottorato, un PhD, lavora come medico in un ospedale privato che paga la retta universitaria».
Problemi anche nel Regno Unito?
Non è tutto oro quello che luccica, certo. Lo diventa solamente mettendo in parallelo quel che succede nel Regno Unito (e altrove) e ciò che accade in Italia: «C’è una grossa crisi a livello globale nella Sanità, ma soprattutto nel mio settore che è la terapia intensiva. Una crisi che si sente molto perché è un settore che ha un’altissima richiesta da un punto di vista delle esigenze umane. Noi siamo al servizio dell’ospedale e aiutiamo le persone a stare meglio, ma non abbiamo ancora le tecnologie per farlo nella maniera più completa. Di per sé, siamo un po’ bloccati».
Non mancano, dunque, aspetti decisamente migliorabili: «Durante le fasi più acute della pandemia, ho visto tanti giovani medici o infermieri in burnout. Abbiamo dato tutto quello che avevamo e l’ho visto sia in Italia che qua a Londra. Osannati prima, odiati dopo. Ma è qui dove ho incominciato a vedere i potenziali delle differenze fra Italia e Regno Unito. In Italia, ho lavorato come medico dal 2014 al 2019. L’ambiente di lavoro è sempre stato orribile». Ed eccoci tornati al punto iniziale dell’intervista al dottor Pietro Arina. A quell’esperienza da incubo vissuta da lui e da altri specializzandi in Italia: «Mi dicevano sempre: “Ma cosa vuoi? Ringrazia che ti facciano lavorare. Non puoi chiedere più soldi. Certo che voi giovani non vi sapete sacrificare”. Io lavoravo in terapia intensiva nel 2018. Facevo 270 ore al mese, che per lo stipendio di allora equivalevano a 5 euro all’ora. Inoltre, a lavoro era la classica lotta fra poveri: niente risorse, niente prospettive. Come può un anestesista che ogni giorno ha sempre meno siringhe, sempre meno farmaci, a portare a termine il suo compito?».
Assistere, intorno a sé, al proliferare di casi di burnout è stato uno dei motivi che l’ha spinto ad accettare quel corteggiamento dal Regno Unito: «Certo, anche qui ci sono degli aspetti negativi. Ad esempio, posso dire che stanno spolpando il sistema sanitario nazionale, che si sta spostando sempre più verso il privato. Però la differenza è che almeno qua in Inghilterra, le persone sono più interessate a una buona qualità della vita».
Il tema della tutela legale
Qualità della vita che passa anche per un altro tema, molto delicato e di stretta attualità. La necessità di sottoscrivere una polizza di responsabilità Civile Sanitaria. In Italia il numero dei medici che si rivolge a broker assicurativi specializzati è in aumento – anche se sono poche, come evidenziato dai dati in possesso di DBDG Insurance Broker, le polizze in grado di dare responsabilità civile e tutela legale – mentre nel Regno Unito è una pratica consolidata da anni. «Rispetto a tre anni fa, io adesso ho un’assicurazione sanitaria privata, che mi sembra una cosa naturale. Cinque anni fa avrei detto: “Uh caspita, ma non ne ho bisogno”. La più grande differenza con l’Italia è che qua non c’è un vero rischio penale per il medico. Quindi si fa molto meno medicina difensiva». Differenze tecniche e sostanziali, che si innestano nel profondo dei servizi sanitari nazionali: «Noi tendiamo ad agire in scienza e coscienza, ma con delle forti linee guida che aiutano molto e c’è proprio un approccio dialogato con il paziente. Non è un caso che i contenziosi siano ridotti. Tra le altre cose, poi, l’NHS ti dà l’assicurazione sanitaria generale, con la possibilità di farne una integrativa. In Italia, invece, ho visto molti colleghi che sono lasciati a loro stessi – ci ha spiegato Pietro Arina – C’è pochissimo supporto da parte della struttura e sei costretto a fare da solo per le spese legali. Anche per questi motivi, molti miei amici italiani stanno facendo assicurazioni integrative, si sentono soli».