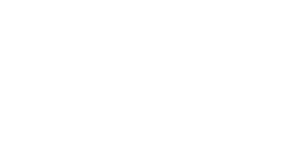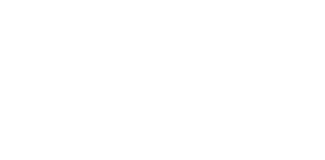I Fratelli Sisters: Jaques Audiard sul suo film “Una fiaba più che un western”
12/04/2019 di Thomas Cardinali
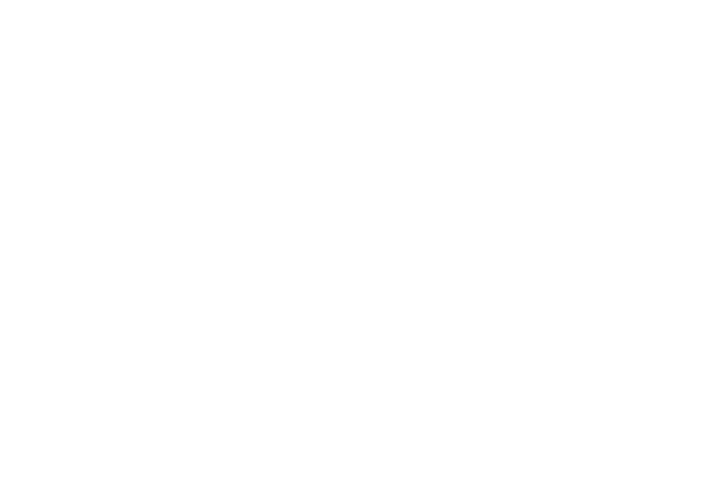
Interessantissimo incontro a Roma col maestro francese Jaques Audiard, che presenta il suo ultimo lavoro “I Fratelli Sisters” che ha già conquistato lo scorso Festival di Venezia.
Durante il Rendez Vous, festival del cinema francese di Roma, abbiamo avuto il piacere di partecipare ad un incontro con il regista francese Jaques Audiard, già vincitore di tanti premi a livello internazionale tra cui una Palma D’Oro al Festival di Cannes per “Dheepan” e un Leone d’Argento a Venezia alla scorsa edizione proprio per il suo “I Fratelli Sisters“. Il cineasta transalpino ci ha raccontato com’è nato un progetto così lontano da lui, che odia il western, ma che è riuscito con grande maestria a caratterizzare in un modo unico unendo diverse tematiche.
I Fratelli Sisters è un percorso iniziatico che mette alla prova il legame di fraternità che unisce i ‘Sisters‘ interpretati da John C. Reilly e Joaquin Phoenix. Pieno di humor nero e di profondità insospettabili, di personaggi truculenti e avventure memorabili, il western di Audiard riprende i codici del genere per deviarli come un treno impazzito nell’America della corsa all’oro.
Con I Fratelli Sisters l’acclamato regista Jacques Audiard prende in mano le redini dei legami di sangue come aveva già fatto in precedenza, questa volta nel contesto del genere western. Audiard e il suo assiduo collaboratore Thomas Bidegain hanno adattato il romanzo di Patrick deWitt The Sisters Brothers, che era stato opzionato da Reilly e Alison Dickey come produttori nel 2011. Ecco cosa ci ha raccontato il regista su questa sua ultima fatica.

Come è arrivato a realizzare “I Fratelli Sisters” che è il suo primo in lingua inglese? È molto più di un western, di cui tra l’altro non sei un appassionato.
“Mettendo ordine il progetto r nato per la volontà di John c reilly che a Toronto mi ha proposto un adattamento del romanzo di Patrick deWitt. Mi sarebbe molto piaciuto come opera letteraria e lo avrei messo da parte proprio perché un western, e quasi un film su ordinazione. Nasce dalla sua volontà di interpretare il ruolo di Eli”.
Il libro è stata un’ispirazione, ma quanto è stato fedele? Lei ha lavorato all’interno dei buchi del western classico, è vero? C’è un po’ di fumetto?
“Non si sbaglia assolutamente, devo dire che questa era un’intenzione già presente nel romanzo. Ha una posizione molto singolare nello sguardo sul western, gli piace raccontare la vita intima e anche i dettagli del l’igiene personale. La masturbazione è invece un mio interesse (ride ndr). Non avendo alcun rapporto mio con il genere western potremo parlare di altri autori come Sergio Leone, mi sono avvicinato a questa storia prendendola un po’ a margine costellandolo di momenti di un racconto di iniziazione. Sono due adulti, ma si comportano come due bambini. Si divertono come fossero in campeggio, è stato un mio modo per affrontare il genere. Vorrei aggiungere che una delle spiegazioni del perché c’è un’azienda di personaggi femminili forti è perché arriveranno dopo quando risolveranno i loro problemi esistenziali. Si la fine è stata rivista più volte, ma per me è un classico come La morte scorre sul fiume”.
Come in ogni suo film anche il western rappresenta una dimensione di frontiera ambientale e esistenziale, come si è rapportato con il paesaggio? Ci sono figure paterne tiranniche e la violenza dei rapporti umani costanti nei suoi film.
“Riguardo ai luoghi il western è fatto di paesaggio e spazi, ma io ho girato il film in Spagna e Romania ma non facendo Il giardiniere mi sono occupato dei miei attori. Sicuramente il rapporto tra gli uomini è uno degli elementi del western che rimanda al mistero esistenziale dei rapporti tra gli uomini ricordiamo il film di John Ford “L’uomo che uccise Liberty Valance”. Sono temi affrontati e che prima o poi dovremo risolvere, l’eredità delle figure paterne e il come venirne a patti è una questione che ho a cuore vedendo ciò che stiamo lasciando al futuro”.
La sua carriera parte come montatore, sceneggiatore e poi regista quindi comunque la lingua ha sempre avuto un’importanza cruciale. Vediamo il contrasto nel titolo del film “I Fratelli Sisters”, anche se non è suo. Questa sua passione per i dettagli linguistici la fa sentire più uno sceneggiatore attento ai dialoghi rispetto allo sfondo narrativo delle vicende?
“Mio padre era uno sceneggiatore e regista e l’eredità familiare va verso la letteratura. Se penso alle raccomandazioni di mio padre riguardano i libri e non c’erano film. La seguo meno rispetto a considerarmi uno sceneggiatore di dialoghi, non mi sento questo. Credo che questa sia una forma di lotta nei confronti di mio padre, sono più uno sceneggiatore di situazioni”.
Sarei curiosa di conoscere le raccomandazioni letterature di suo padre, ma questo film è girato in inglese e si cambia il messaggio cinematografico linguistico.
“Mio padre mi ha detto di leggere Proust e mi trovo a ricascare sempre su “All’ombra delle fanciulle in fiore”. Riguardo invece alla lingua sono costretto a constatare che ho girato gli ultimi due film in una lingua che non era mia, e capisco l’inglese molto meno di quanto possiate credere. Volevo distanziarmi da qualcosa che conoscevo per modificare il mio rapporto con gli attori modificando anche il rapporto con le aspettative delle loro interpretazioni. È come se avessi lasciato spontaneamente un rapporto intellettuale per uno più musicale con queste ultime scelte”.
Quando un regista non americano affronta un western non si può non pensare a Sergio Leone. Anche se non ama il genere che rapporto ha con il suo cinema?
“Sergio Leone è un cineasta che ammiro più di quanto non ami i suoi film. Riconosco e ammiro nei suoi western un’audacia formale unica, una capacità di sintetizzare il pensiero che suscita grande emozione. Amo paradossalmente meno “C’era una volta l’America” rispetto ai western, ma siamo debitori a lui e la sua influenza continuerà nel tempo. Non sarei ora in grado di raccontare la storia dei suoi film, ma le sue immagini resteranno per sempre nella mia mente insieme alle note e ai suoni. Avrei voluto potergli fare qualche domanda”.
Come succede raramente con i film che lavorano sui codici si fa prima a dire cosa non è “I Fratelli Sisters”. Dovendosi confrontare con l’immaginario americano come ha lavorato? C’è stata qualche ispirazione?
“E una domanda molto vasta e la risposta complessa. Abbiamo affrontato più volte questo film perché ci sembrava un’impresa impossibile. Ad un certo punto abbiamo immaginato una visione completamente notturna, con personaggi come vampiri. Lo abbiamo immaginato per spingere agli estremi le immagini del film, ad un certo punto abbiamo cercato di farlo giocare tutto sulla sequenza di apertura per poi cambiare idea. Poi abbiamo cominciato a pensare cosa ci fosse tra i due personaggi, ci siamo resi conto che l’unica forma che potesse inglobare tutto era un immaginario fiabesco. Abbiamo caldeggiato l’idea di girare il film in bianco e nero, ma poi abbiamo deciso di no. Abbiamo usato dei colori saturi come se fosse un disegno con i pastelli”.
Questo è il settimo film che ha fatto Alexandre Desplat e lui ha detto che è il regista che gli tira fuori meglio le musiche, cosa la attrae di questo compositore? Come avete lavorato?
“Con Alexandre Desplat abbiamo fatto insieme il mio primo film, ben 30 anni fa e fa impressione pensarci. È stato gentile ma credo che lavorare con Wes Anderson non deve essere stato male per lui in “Grand Budapest Hotel”. Non so bene perché ci scegliamo, non è vero che non ho immaginazione per pensare ad altri. Ammiro il talento di Alexandre che ha un talento singolare e vario, siamo amici e va sottolineato. Il rapporto è molto cambiato dai primi film. Lui mi dava già delle registrazioni sul set, ora invece aspetta di vedere il film con le immagini per le musiche. Io utilizzo sia le sue musiche originali sia una musica pre esistente, per me si tratta di utilizzare quest’ultima per dare un’idea di scorrimento del tempo mentre i suoi brani mi servono per dare una caratterizzazione ai personaggi”.
È un film sull’identità? Quanto è pericoloso imporla?
“Sicuramente è un romanzo di formazione, un racconto di formazione sull’identità è come ciascuno crea la propria rispetto agli altri”.
Mi racconta qualcosa dell’effetto “Mano Negra” davanti all’obiettivo?
“Posso rispondere che molto tempo fa quando realizzavo i miei primi film con una macchina sperimentale è basilare si potevano solo fare riprese fotogramma per fotogramma, senza permettere alcuna raffinatezza. Per poter fare la dissolvenza la simulavo con la mia mano, ora faccio la stessa cosa con una tecnologia più avanzata”.
Perché John c. Reilly era così interessato al romanzo?
“Era molto interessato perché è arrivato ad un punto della sua carriera in cui ha provato molti ruoli da caratterista comico. Il sistema americano Sto arrivando! Essere duro e claustrofobico di passare da un livello ad un altro e lui voleva darlo, ha voluto farlo con un regista straniero”.
L’eterno ritorno del western che ciclicamente torna nelle serie e nei film, pensiamo ultimamente a registi come Quentin Tarantino. Perché è immortale?
“Le fortune sono diverse sui ritorni, a volte si ha la sensazione di girare a vuoto. Ho fatto il punto dei western negli ultimi cinque anni quando dovevo realizzare il mio e non mi sembra che ci siano state opere così compiute”.