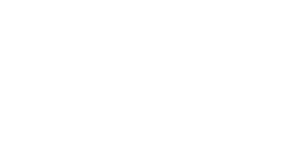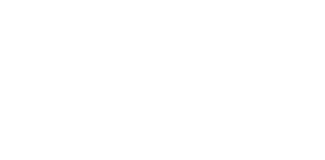Dallo schiaffo all’assuefazione: se una foto diventa il simbolo dell’immigrazione
26/06/2019 di Daniele Tempera
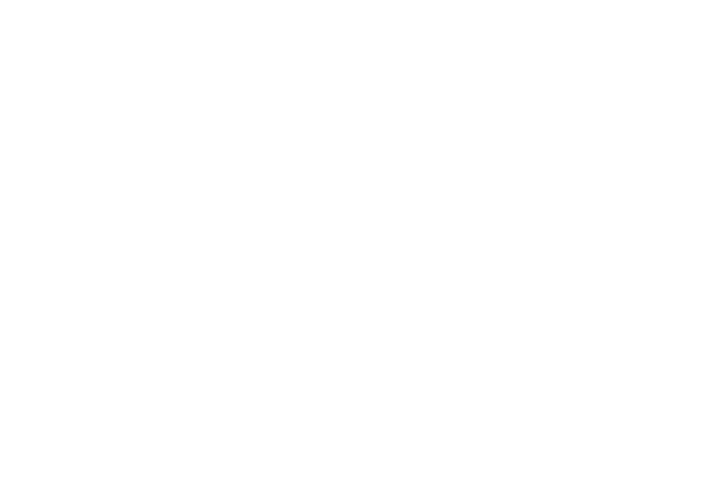
Cambiano le coordinate, rimangono le immagini. Fotogrammi di una narrazione vecchia quanto il mondo, ma che tende a identificarsi con il dramma del XXI secolo. Non sappiamo come gli storici del futuro interpreteranno le storie dei diseredati che attraversano, tra immani sofferenze, i nostri mari e i nostri confini, le misure spesso disumane che i “democratici” governi occidentali adottano per trincerarsi dall’arrivo dei disperati o le fortune elettorali e il prezzo sociale e culturale che questa dinamica scatena. Di certo ci sono foto destinate a entrare di forza nell’immaginario storico e collettivo, come quelle della “Grande Depressione”, come gli scatti che ci hanno raccontato la Seconda Guerra Mondiale o la Guerra del Vietnam. Sì, perché anche in un universo basato sulle immagini e sullo “spettacolo” a presa continua, difficilmente si può ignorare uno scatto come quello che da ieri rimbalza sui quotidiani americani e, conseguentemente, su quelli di mezzo mondo.
Padre e figlia di due anni, migranti, sono annegati nel Rio Grande cercando di raggiungere la speranza.
I muri, i blocchi e la propaganda di odio hanno un solo effetto: producono morte. #SavingHumans pic.twitter.com/fyPheyA6Lt
— Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) June 26, 2019
La foto ritrae due immigrati salvadoregni, padre e figlia di due anni, morti sul Rio Grande, nel tentativo di superare quel confine che Donald Trump cerca di sigillare ermeticamente. Quel confine che, ribadisce a ogni comizio, deve diventare invalicabile. Colpisce l’estremo tentativo dell’uomo di tenere stretta a sé la figlia: il gesto di un padre che non si rassegna a un’ingiustizia più grande della vita e della storia. Secondo le autorità federali i due sarebbero morti per disidratazione e per il troppo caldo. E mentre la foto rimbalza per i telegiornali di mezza america e la Casa Bianca tace, a noi europei tornano in mente altri immagini.
Cosa ci ha insegnato la storia di Alan
Per esempio il fotogramma che riporta alla memoria il dramma del piccolo Alan, il bambino siriano di tre anni, trovato morto su una spiaggia turca. Era il 2012, la sua foto fece il giro del mondo e diventò il simbolo del dramma dei siriani in fuga da una guerra lacerante. Fu anche grazie a quello scatto, e alle tante scene di ordinaria barbarie e disperazione che venivano dalla cosidetta “Rotta Balcanica” , che Angela Merkel decise di accogliere i siriani in fuga. Una scelta sicuramente non popolare, ma che diventò un gesto di consapevolezza verso le responsabilità occidentali nei confronti degli ultimi del mondo.
Ma a sette anni di distanza, non si può dire che il sacrificio di Alan, e di tutte le altre vittime innocenti di una diaspora che non accenna a sanarsi, abbia sortito gli effetti sperati. “La compassione è un’emozione instabile che deve essere tradotta in azione, o appassisce” scrive Susan Sontag in quel saggio essenziale per comprendere l’importanza delle immagini nel mondo contemporaneo che è “Di fronte al dolore degli altri”. Secondo la grande studiosa americana, anche a causa della velocità e dell’abbondanza di immagini riprodotte, il rischio che ci si intorpidisca di fronte alle immagini che mostrano atrocità è reale. Dallo schiaffo all’assuefazione. Un’evidenza ribadita da questi anni di populismi e xenofobia che sono seguiti alla pubblicazione della foto drammatica del piccolo siriano. Far sì che non accada spetta a tutti noi. E la foto è un punto di partenza: solo le azioni concrete (e politiche) possono far sì che la compassione “non evapori”.