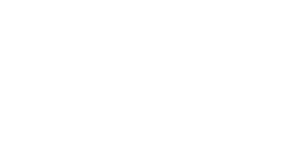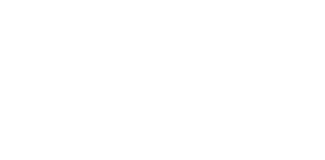La sentenza della Cassazione sul parlare male dei capi via Whatsapp che non può portare a licenziamento
Tutto è partito da un lungo contenzioso tra un dipendente la e società di sicurezza di Udine per cui lavora
14/04/2022 di Enzo Boldi
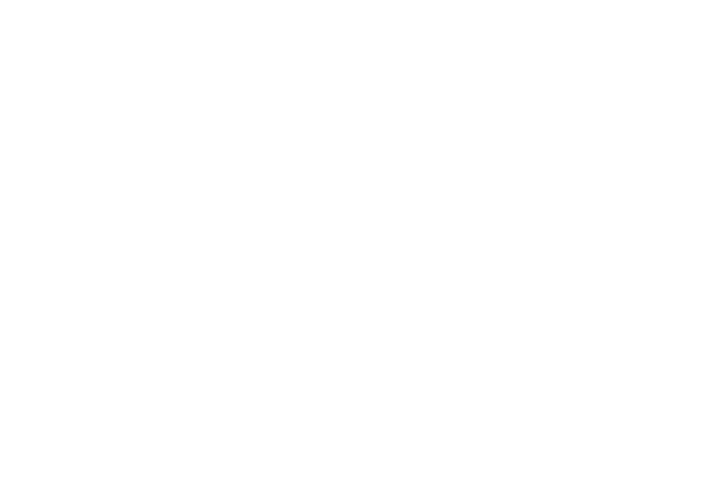
Non è un “libera tutti”, ma un’indicazione ben precisa che restituisce alle conversazioni via app di messaggistica istantanea un peso più contingente con la realtà dei fatti. Con una sentenza depositata dalla Quarta Sezione Lavoro in data 12 aprile 20221, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una società che si occupa di sicurezza privata a Udine nei confronti di un dipendente reo di aver parlato male dei propri capi utilizzando Whatsapp. Una vicenda che restituisce il giusto valore all’utilizzo di mezzi di questi comunicazione.
LEGGI ANCHE > «Vi spiego come Le Alternative è stato deindicizzato da Bing e – attenzione – da DuckDuckGo»
La sentenza numero 11665/22 della Quarta Sezione Lavoro della Corte di Cassazione offre alcuni spunti di riflessione che creano un precedente che farà giurisprudenza. La vicenda nasce a Udine, dove un dipendente di una società di vigilanza privata era stato “pizzicato” nel dare giudizi di scarso apprezzamento nei confronti dei vertici dell’azienda. Questo era solamente una delle tre contestazioni, ma quella che crea sicuramente l’esigenza di un approfondimento. Quei messaggi sono stati rinvenuti sul pc utilizzato dall’uomo che, probabilmente, aveva lasciata aperta sul proprio browser la pagina di Web Whatsapp, la versione per pc della nota applicazione di messaggistica istantanea.
Una conversazione avvenuta, dunque, in un contesto privato ed extra-lavorativo, come sottolineato dai giudici. Ma l’azienda aveva deciso di licenziare il suo dipendente adducendo una tesi: il fatto di aver utilizzato una piattaforma come WhatsApp avrebbe amplificato (almeno potenzialmente) la portata di quei giudizi e di quelle parole che avrebbero messo in cattiva luce il presidente e gli amministratori delegati dalla società di vigilanza privata.
Whatsapp, parlare male dei capi non porta a licenziamento
Insomma, per sintetizzare: l’azienda aveva inserito tra i motivi del licenziamento per giusta causa non solamente quei pensieri, ma il fatto di averli espressi su un mezzo di comunicazione (seppur in una conversazione privata ed extra-lavorativa) che poteva generare un effetto megafono. Ma per i giudici della Quarta Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, questa tesi è da respingere in quanto il mezzo di comunicazione – in questo caso Whatsapp – non ha profili rilevanti e non può essere utilizzato come un0’aggravante per la valutazione di un comportamento di un privato cittadino. Nello specifico, i giudici ermellini hanno scritto:
«Premesso che non integra una condotta in sé idonea a violare i doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto l’aver espresso in una conversazione privata e fra privati, giudizi e valutazioni, seppure di contenuto discutibile, ove, come nel caso in esame, sia stato escluso in fatto che tali dichiarazioni fossero anche solo ipoteticamente finalizzate ad una ulteriore diffusione, resta irrilevante lo strumento di comunicazione utilizzato. Tali dichiarazioni dovevano essere valutate specificamente nel contesto in cui erano state pronunciate, vale a dire in una conversazione extralavorativa e del tutto privata senza alcun contatto diretto con altri colleghi di lavoro [..] Con la conseguenza che anche sotto il profilo soggettivo le stesse erano circoscritte ad un ambito totalmente estraneo all’ambiente di lavoro».
L’utilizzo del mezzo, Whatsapp, non funge da megafono. Anche perché si trattava (in questo caso specifico) di una comunicazione privata ed extralavorativa. Ovviamente, qualora comunicazioni di questo tipo fossero avvenuto in un contesto differente con il coinvolgimento di più persone, la sentenza avrebbe sicuramente approfondito altri temi come quello dell’ingiuria e della querela, sempre in base a ciò che viene detto e/o scritto. Insomma, una conversazione via messaggio è pari a parole pronunciate nelle quattro mura di casa.
Il caso “bimbominkia”
Questa sentenza arriva a pochi giorni da un’altra che ha provocato moltissime reazioni. Secondo i giudici della Corte di Cassazione, infatti, definire “bimbominkia” una persona sui social, nelle chat di videogame o similari è un reato di diffamazione. E, secondo la sentenza 12826/22 della Sezione Civile della Corte di Cassazione, diventa diffamazione aggravata qualora sia scritta – in modo diffamatorio – in un gruppo Facebook con almeno 2mila iscritti. E la Suprema Corte ha motivato così questa decisione: questa parola «non è coperta dal diritto di critica, perché si colloca al di là del requisito della continenza richiesto per applicare la scriminante».